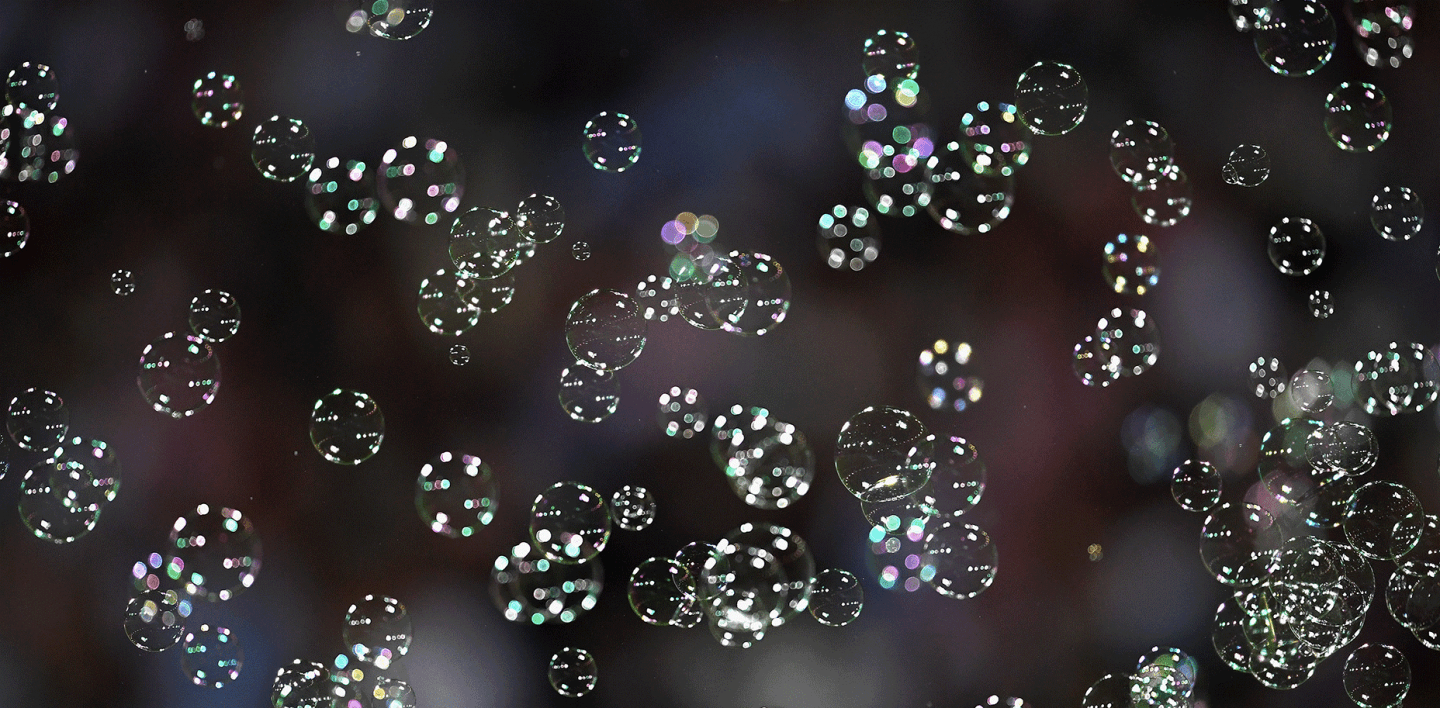
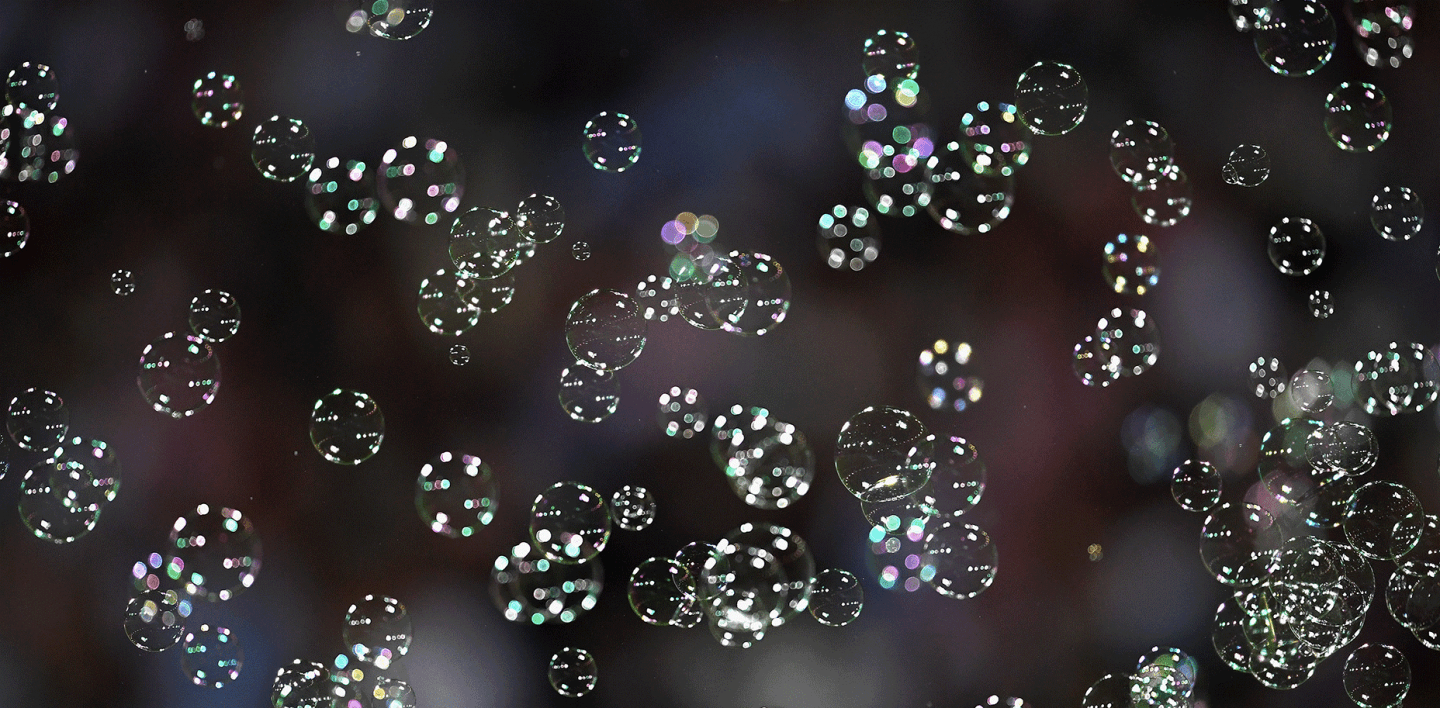
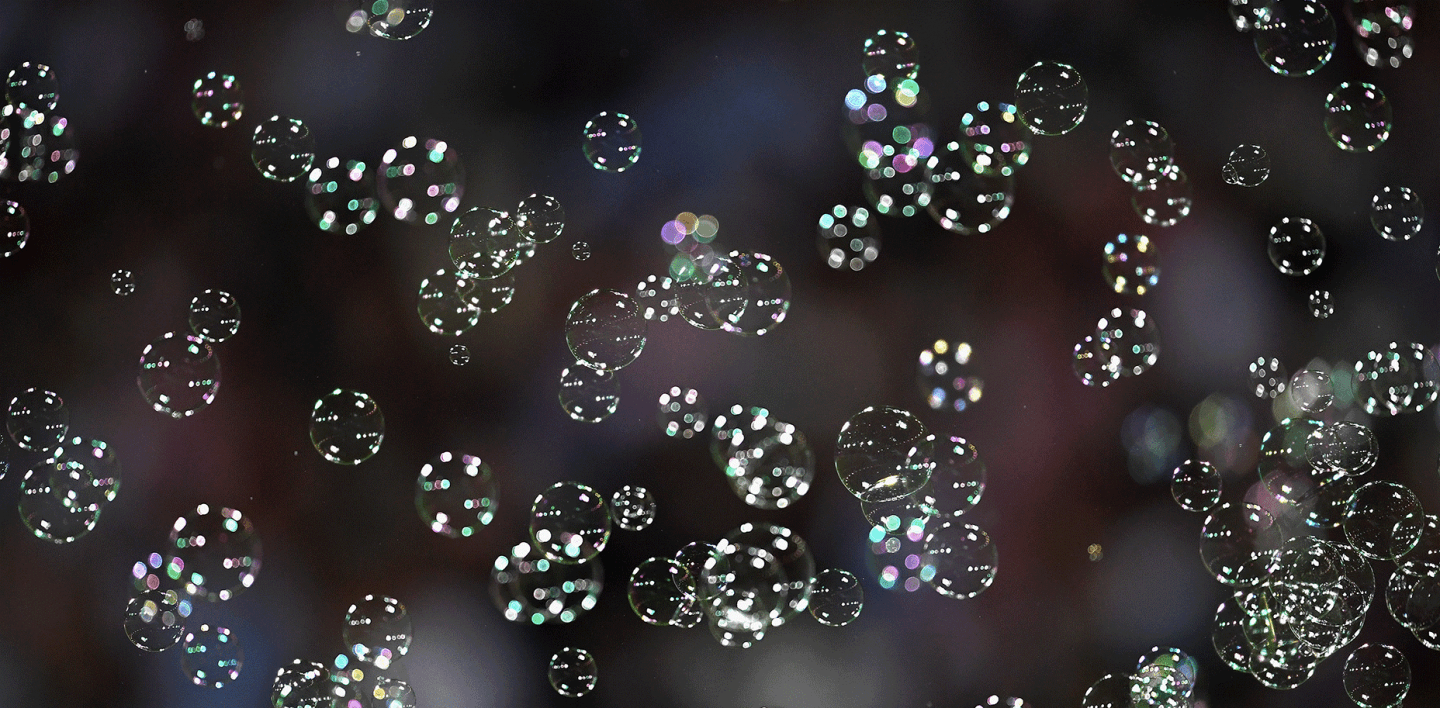
N el 2011 esce in America Il filtro. Quello che Internet ci nasconde (Il Saggiatore 2012) di Eli Pariser, un saggio che inventa il termine filter bubble (spesso tradotta anche come “bolla” o “camera dell’eco”), denunciando la crescente personalizzazione delle informazioni in rete. Negli anni successivi alla diffusione del web chiunque utilizzasse la rete aveva accesso a tutte le pagine, che si presentavano uguali per chiunque: i contenuti erano in grandissima parte pubblici e indicizzati dai motori di ricerca. Oggi non è più così: è un processo iniziato da qualche anno, in particolare da quando Google ha iniziato a mostrare risultati diversi a seconda di chi sta effettuando la ricerca.
La personalizzazione dipende da informazioni molto diverse tra di loro: si va dalla posizione all’orario, dalla cronologia di navigazione (quello che si è cercato e quello su cui si è cliccato) al programma usato. Anche Facebook ha seguito la stessa strada, proponendoci contenuti (e pubblicità) tagliati sui nostri comportamenti, per cui noi non vediamo tutto quello che viene pubblicato dalle persone e dalle aziende che scegliamo di seguire, ma solo quello che viene pubblicato dalle persone e dalle aziende con cui abbiamo interagito (non per forza su Facebook, ma anche su WhatsApp, Messenger e Instagram, tutti di sua proprietà). Non vale solo per Google o per Facebook, ovviamente: la personalizzazione arriva a modificare i prezzi dei prodotti e dei servizi, che in buona parte sono ormai dinamici, cioè cambiano a seconda di chi, quando e dove li cerca. Anche la possibilità di decidere se far vedere a tutti i nostri contenuti, modificando le impostazioni della privacy, significa che molte pagine sono nascoste ai motori di ricerca e alle persone fuori dai nostri contatti: in sintesi, il web non è più del tutto pubblico e ricercabile.
La personalizzazione è una buona soluzione a un problema reale: il sovraccarico di informazioni. Neanche dieci anni fa Clay Shirky, consulente e ricercatore, diceva “non è eccesso di contenuti, ma fallimento dei filtri”. Se oggi ci lamentiamo dell’eccesso dei filtri è perché questi hanno un possibile effetto collaterale, e cioè la progressiva sparizione della diversità dal nostro orizzonte socio-culturale. Quella di Pariser è una teoria semplice, elegante e convincente, che però subisce una pesante lettura strumentale: la maggior parte delle persone che la apprezza, la usa o la cita non prende però in considerazione il contesto in cui l’autore la colloca. Pariser cioè lamenta la fine della rete democratica e uguale per tutti, ma viene troppo spesso usato per lamentarsi dell’avvento della rete tout court. Esattamente il contrario del suo pensiero, ovvero, “abbiamo davvero bisogno che Internet sia quello che sognavamo che fosse”.
Vale la pena ricordare chi è Eli Pariser e come è arrivato nel 2011 sul palco di TED a lanciare questa sfida ai giganti della rete. All’indomani dell’11 settembre 2001, a soli 22 anni, creò il sito 9-11peace.org (oggi non più attivo) per chiedere una risposta non militare all’attentato terroristico. Il sito raccolse dal nulla mezzo milione di firme, portandolo alla direzione e poi alla presidenza di MoveOn.org, piattaforma utilizzata per raccogliere e spingere ad agire concretamente chi voglia cambiare le cose. Pariser è un professionista nato e cresciuto in rete, un attivista politico capace di unire le posizioni di milioni di persone usando con efficacia i media digitali, un imprenditore che ama e sa usare alla perfezione la rete. Uscendo da MoveOn ha fondato Upworthy, una testata giornalistica che confeziona notizie virali, pensata per dare corpo all’idea che “siamo tutti parte della stessa storia”, per mettere cioè in pratica, in rete, il suo ideale di una rete uguale per tutti.
Le camere dell’eco sono sempre esistite e i media sono sempre stati un antidoto alla loro permanenza.
La preoccupazione sui filtri e sulla personalizzazione è in crescita perché diminuendo la diversità delle fonti a disposizione in rete rischiamo di rinchiuderci in gruppi di persone simili a noi e con idee identiche alle nostre, creando quelle che vengono spesso definite “camere dell’eco”, cioè ambienti in cui sentiamo solo la nostra voce, convincendoci che sia la verità. È così che le cosiddette post-verità (o post-fatti) si consolidano, portando molti osservatori ad attribuire molte inattese svolte politiche (da Brexit all’elezione di Trump al No al Referendum) alla diffusione di dati, informazioni e notizie false, ma convalidate dal gruppo di pari in cui rischiamo di finire senza neanche accorgercene. Ma quando Pariser denuncia la personalizzazione dei risultati di una ricerca di Google o l’impatto dei filtri sulla nostra timeline di Facebook non sta confrontando le “camere dell’eco” digitali con la società precedente a Internet, ma con la Internet precedente ai filtri.
La tesi di Pariser è stata insomma vittima di una fallacia logica della stessa categoria e gravità dell’attenzione selettiva che alimenta le bolle: la tendenza umana a prendere di una teoria solo quello che conferma le nostre posizioni, ignorando quello che ci impone di allargare lo sguardo. Le camere dell’eco sono sempre esistite e i media sono sempre stati un antidoto alla loro permanenza: come spiega benissimo Joshua Meyrowitz in Oltre il senso del luogo (Baskerville 1985), la televisione è stato il catalizzatore del femminismo e dei movimenti del ’68 semplicemente perché ha mostrato persone in luoghi diversi che vivevano in modi diversi dai nostri. Per usare le parole dell’autore: “la mia tesi fondamentale è che molte differenze che una volta si percepivano tra individui appartenenti a diversi gruppi sociali, a diversi stati di socializzazione e a differenti livelli di autorità, erano sostenute dalla suddivisione degli individui in mondi di esperienza molto diversi.”
Non c’è peggior ambiente chiuso e refrattario a posizioni diverse di un paesino, di una famiglia, di votare quello che dice il parroco o di leggere tutta la vita un unico giornale, magari di proprietà di una fabbrica: eppure tantissime persone anche colte e intelligenti hanno sposato con entusiasmo una teoria prendendone solo la parte in cui credevano già, e cioè che Google e Facebook ci stanno costringendo al pensiero unico. Cosa dice invece Pariser? Dice che Google e Facebook hanno reso la rete – un ambiente libero e aperto – più simile alla società precedente di quanto lo fosse alle sue origini: un luogo in cui vedi e trovi solo quello che pensi già, che conosci già, che non ti mette in discussione. Il titolo della seconda edizione del libro in cui espone la sua tesi (non uscita in Italia) lo dice chiaramente, mettendo l’accento sulla parola “new”, non sulla parola “web”: The Filter Bubble: How the New Personalized Web Is Changing What We Read and How We Think. Insomma, secondo Pariser sarebbe la nuova rete personalizzata a cambiare come leggiamo e come pensiamo, non la rete in sé.
La comprensione di come si formano e consolidano le camere dell’eco serve non solo a fare chiarezza (cosa che non guasta) nel presente ma anche a evitare nuovi, tragici errori in futuro, come per esempio permettere, anzi, chiedere a Facebook e Google (e ai loro pari) di decidere tra verità e finzione, tra giusto e sbagliato, tra rilevante e secondario. Per combattere gli effetti dei filtri stiamo chiedendo più filtri e filtri più invasivi, e non filtri migliori o filtri aperti. Aperti come le persone, e qui sta, secondo me, la debolezza dell’idea di Pariser, affascinante ma limpidamente riduzionista. L’idea che l’impatto dei filtri digitali sia tale da trasformare una persona colta e curiosa in un’ameba o da impedire a una persona di cambiare idea è figlia della convinzione che siano le macchine a farci fare cose, e non noi a far fare cose alle macchine. È infatti vero che i filtri rischiano di restringere lo spettro di diversità proposto dai mezzi di comunicazione, ma è anche vero che sono stati una soluzione all’eccessivo rumore di fondo che avrebbe comunque complicato e peggiorato la qualità dell’ecosistema dell’informazione. È possibile una soluzione migliore? A mio parere sì, ma pochi sembrano averne voglia, e il timore di Pariser è diventato una profezia autoavverante.
Spesso il debunking, l’atto di smontare le bufale, assomiglia a una lezione impartita al buon selvaggio con un linguaggio molto più adatto a consolidare il legame con chi la pensa come noi che a creare un ponte con chi la pensa diversamente.
Vogliamo davvero credere che un software non possa essere programmato in modo diverso o migliore da come lo vediamo adesso? Vogliamo davvero credere, per esempio, che l’enorme crescita dei volumi di conversazioni digitali impedisca a un algoritmo soluzioni scalabili di gestione della violenza e dell’aggressività, o di proporci opinioni e contenuti in modo evolutivo e non in modo conservativo? Lo dice lo stesso Pariser nel suo TED del 2011: un algoritmo potrebbe proporci non solo quello che già ci piace e che è facile da consumare, ma anche qualcosa che ci stimola, ci incuriosisce, ci mette in difficoltà. E se questo algoritmo non dovesse incontrare il gradimento di milioni di persone che vogliono restare a mollo nella loro comfort zone il problema è del software o della società?
Molto si può fare anche modificando lo stile con cui ci si confronta e ci si mette in relazione, perché una rasoiata di Occam alla teoria delle camere dell’eco mi porta a pensare che se non capisco un pensiero diverso dal mio non ho modo di prenderlo in considerazione, soprattutto quando è espresso in modo paternalista o con il disprezzo tipico di chi per lavoro dovrebbe informare (e non insegnare). E se le bolle non si consolidassero intorno ai contenuti, ma intorno alla forma che questi prendono? Se io scegliessi contenuti che capisco, più che contenuti simili a quello che già penso?
Tanti anni fa ho avuto la fortuna di intervistare Ester Dyson, l’imprenditrice che nel 1997 ha scritto Release 2.0, uno dei primi libri a interrogarsi sull’impatto di Internet nelle nostre vite, e non ho mai dimenticato due sue affermazioni. La prima è che non vogliamo più entrare in relazione con chi non ci vede e ci tratta come pari. La seconda è che le comunità spontanee, prima che geografiche o tematiche, sono linguistiche (in senso sia geografico, di lingua nazionale, sia tematico, delle parole e dei riferimenti che usiamo). Nella maggior parte dei casi chi lavora per smontare le bufale è animato da un pesante disprezzo nei confronti di chi le segue e le diffonde, e chi scrive per spiegarti che non hai capito niente e sei un cretino lo fa usando il suo linguaggio, non il tuo.
Tutto il contrario della buona scrittura divulgativa, che come sintetizza Steven Pinker nel suo The sense of style consiste nel mostrare a un proprio pari, come in una chiacchierata, qualcosa che da solo non riesce a vedere, ma una volta condiviso è immediatamente chiaro. Quasi sempre invece il debunking, l’atto di smontare le bufale, assomiglia a una lezione impartita al buon selvaggio con un linguaggio molto più adatto a consolidare il legame con chi la pensa come noi che a creare un ponte con chi la pensa diversamente. È concepibile dare ascolto e attenzione a chi ci tratta con paternalismo? Io non credo (e non è sarcasmo).
Anche se fosse vero che il “nuovo web personalizzato” ci impedisce di vedere altro da noi, viviamo ancora in un ambiente ricco di stimoli per chi è interessato a raccoglierli.
Prima di correlare strettamente camere dell’eco, diffusione delle bufale e tendenza a voler vedere solo quello in cui già si crede (come hanno fatto tutti quelli che hanno costretto Pariser ad aggiungere un “new” nel titolo della seconda edizione) dovremmo provare a trovare, usare e negoziare un linguaggio diverso, una terra di mezzo comune. Solo quando avremo seriamente e sinceramente eliminato il disprezzo dal debunking potremo prendere in considerazione la prima e più semplice ipotesi, cioè che chi crede a una bufala non è minimamente disposto né ad approfondire né a cambiare la propria posizione; che il problema quindi non sia tanto nelle informazioni presentate, quanto nella capacità delle persone di accettare una visione del mondo diversa da quella con cui hanno familiarità. Un debunking fatto bene non ci garantisce di ottenere il risultato desiderato (evitare la diffusione di notizie e informazioni sbagliate), ma è un tentativo doveroso. Pensiamo per esempio alla disinformazione sui vaccini: l’esempio di Bebe Vio potrebbe rivelarsi molto più efficace di moltissimi articoli e post informativi, proprio perché lo stesso messaggio viene fatto passare con un sorriso e con gentilezza, senza colpevolizzare chi la pensa diversamente.
L’incredibile aumento della potenza dei computer degli ultimi anni ci permette non solo di misurare più dati e di superare i limiti che rallentano ancora la ricerca, ma ci fa anche sperare di poterli misurare e comprendere in modo diverso. Possiamo cioè finalmente studiare il pensiero, la società e la comunicazione come un sistema aperto e collegato e non chiuso e isolato; per usare le parole del fisico Giuseppe Vitiello, “il cervello è permanentemente accoppiato con l’ambiente esterno, esso è un sistema intrinsecamente aperto”. Non possiamo ragionevolmente credere a un pensiero isolato che subisce una riduzione delle scelte a disposizione contro la sua volontà, anche perché la restrizione delle possibilità a nostra disposizione, una restrizione invisibile, secondo Pariser, avviene comunque in uno solo degli ambienti che frequentiamo (Internet), lasciandoci esposti ad altri stimoli in altre situazioni (colleghi, amici, media tradizionali, l’ambiente in cui vivo).
Anche se fosse vero che il “nuovo web personalizzato” ci impedisce di vedere altro da noi, viviamo ancora in un ambiente ricco di stimoli per chi è interessato a raccoglierli. La prima post-verità da cui liberarsi è ancora questa: pensare che gli ambienti digitali siano un mondo a sé, che non influenza e non è influenzato dalla realtà di cui invece sono parte integrante. Realtà che dipende dalle nostre scelte: per bucare le bolle dei filtri è sufficiente cercare esperienze diverse, perché la personalizzazione del web rispecchia quello che facciamo. Onore a Pariser per aver sollevato il problema: non facciamogli il torto di usare il suo pensiero per non prenderci le nostre responsabilità.