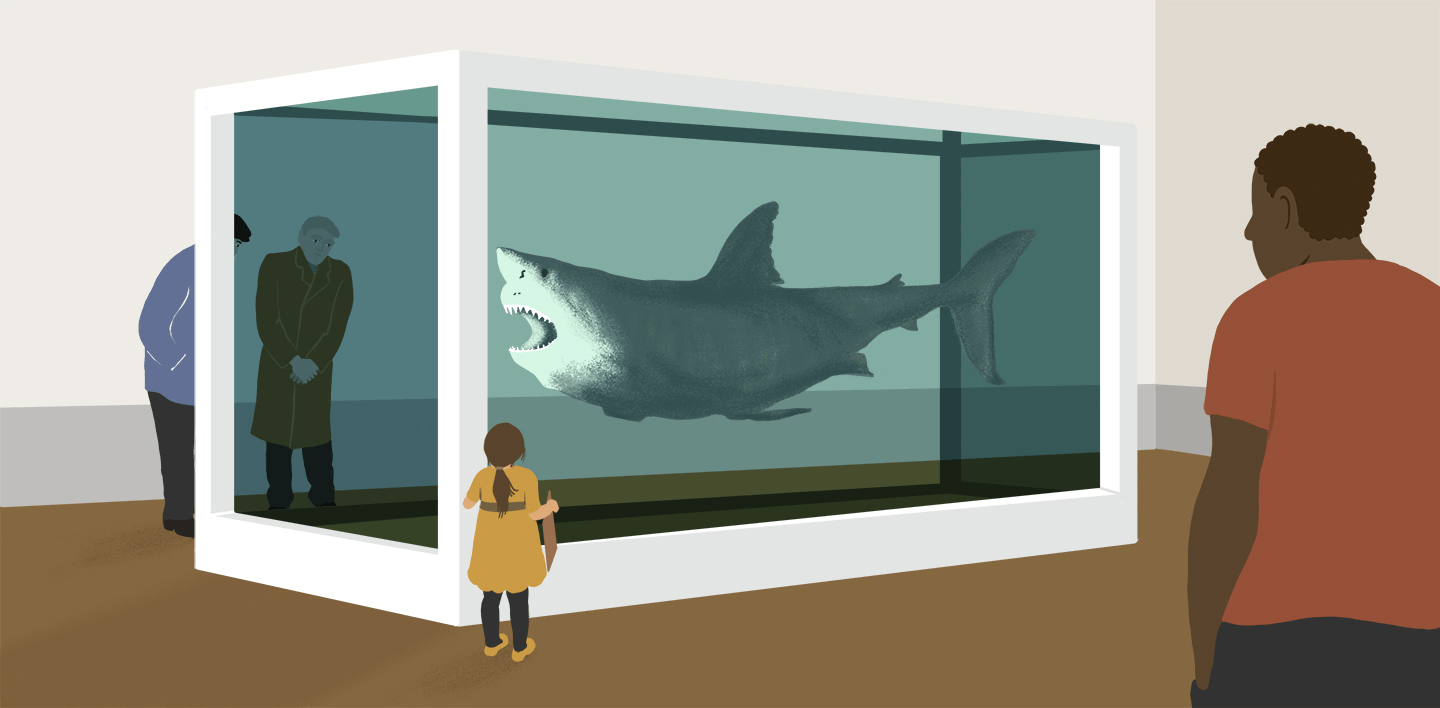
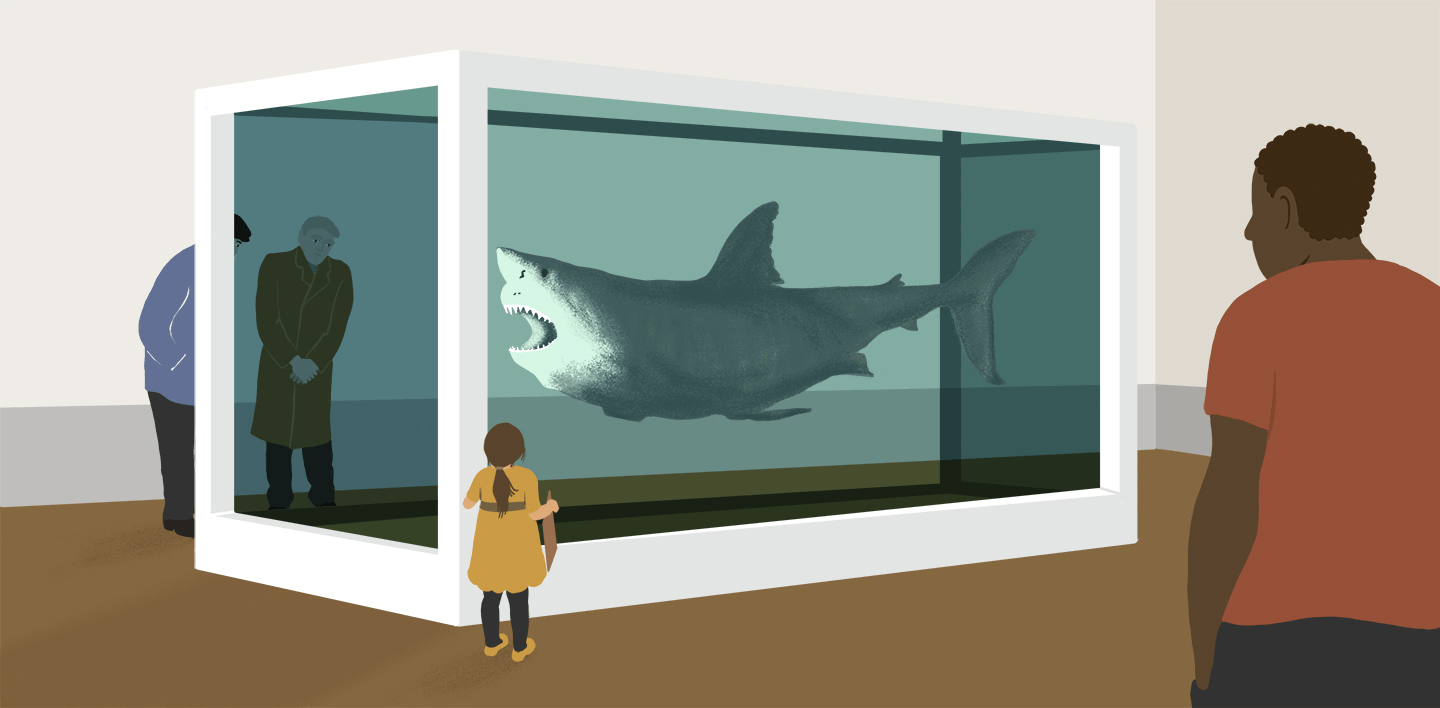
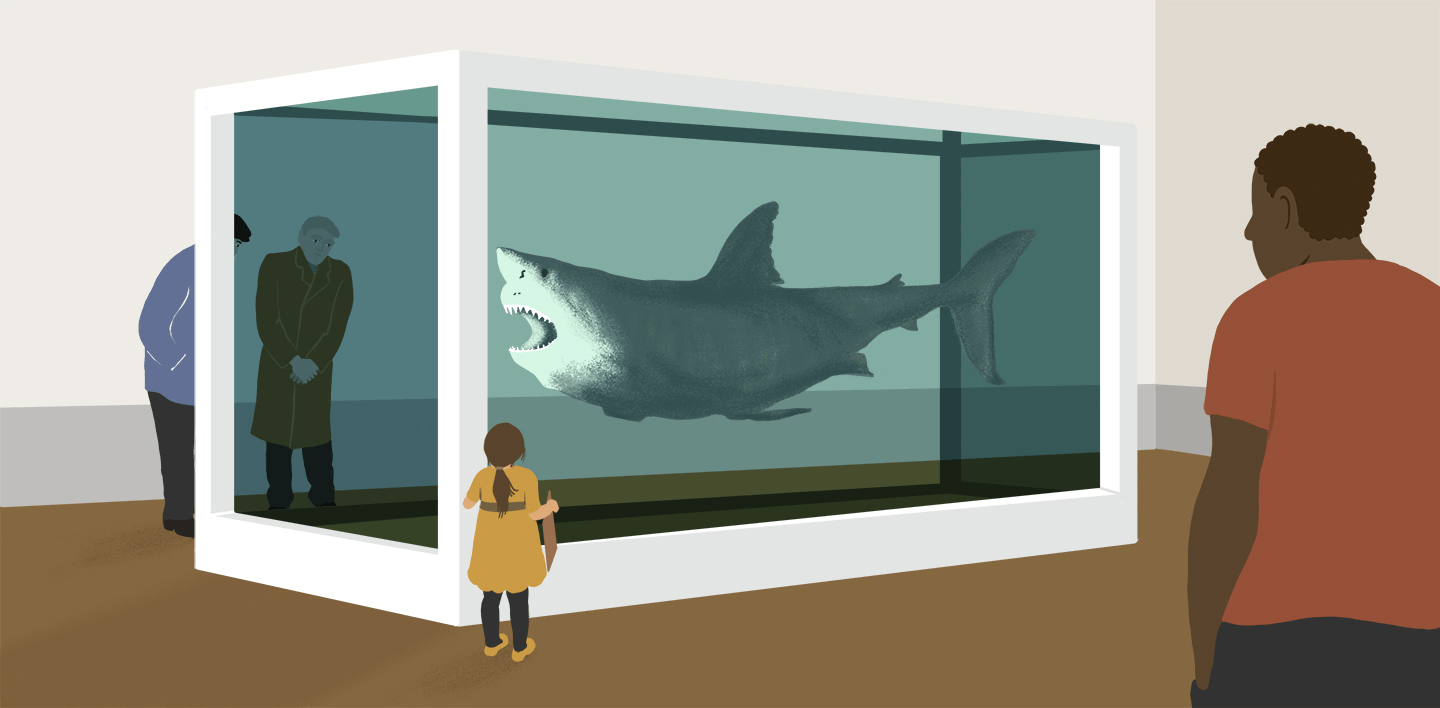
Un giorno, tutto questo, è il tema della trentunesima edizione del Salone Internazionale del Libro che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio. Il Tascabile partecipa al progetto 5domande ideato quest’anno dal Salone, un questionario nato per “riflettere sul mondo in cui viviamo e sul mondo che ci aspetta, e la cui forma dipenderà evidentemente anche da noi”. Abbiamo risposto alle 5domande girandole a donne e uomini arrivati sul Tascabile dai percorsi più diversi: dallo sport all’astrofisica, passando per l’arte contemporanea. Il futuro non è ancora scritto: c’è chi però, raccontandolo, può aiutarci a cambiarlo.
Oggi ci siamo chiesti: a chi appartiene il mondo? Tra cent’anni la nostra Terra potrebbe essere meno accogliente di oggi. La forbice tra ricchi e poveri si allarga. Il lavoro si trasforma e può ridursi. Milioni di persone sono costrette a lasciare la propria casa. Di chi è il mondo? Chi deve prendersene cura?
Paolo Pecere – filosofo, scrittore
«Siete perduti se dimenticate che i frutti sono di tutti, e che la terra non è di nessuno!», scriveva Rousseau nel Discorso sull’origine della disuguaglianza, contestando l’istituzione della proprietà privata, e Voltaire, campione dell’illuminismo borghese, commentava a margine della sua copia: «Questa è la filosofia di un pezzente che vorrebbe che i ricchi fossero derubati dai poveri». Dopo oltre due secoli dalla nascita di queste visioni contrapposte all’interno della cultura liberal-democratica, non soltanto la disuguaglianza economica globale è in aumento, ma è posta in questione una premessa su cui tutti gli illuministi convenivano, ovvero il diritto incondizionato dell’uomo di sfruttare le risorse naturali della terra. L’esaurimento delle risorse petrolifere, la tendenziale scomparsa delle foreste, la carenza d’acqua in vaste aree del pianeta e l’esodo di masse di rifugiati climatici sono questione di pochi decenni, e incideranno enormemente sulla lotta per la ricchezza, mentre imprese e stati nazionali si occuperanno sempre più di protezione e intrattenimento, recintando le comunità di individui più ricchi. Ma chi potrà occuparsi di impedire che la festa finisca con una catastrofe bellica o ecologica?
Come ricorda Amitav Ghosh ne La grande cecità, il documento degli accordi di Parigi del 2015 presenta il problema del cambiamento climatico con toni sfumati, e non lo collega con quello della disuguaglianza, mentre nello stesso anno l’enciclica Laudato si’ di papa Francesco parla di imminente «catastrofe» ambientale e insiste che «un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri». I due temi sono indubbiamente intrecciati, perché la pretesa di sviluppo dei paesi ex-coloniali e asiatici è incompatibile con l’impatto ambientale già insostenibile dello stile di vita occidentale, il cui mantenimento presuppone che la povertà di massa si mantenga e cresca. Ghosh ha ragione a dire che si tratta di un problema che gli stati nazione sono costituzionalmente incapaci di affrontare, in quanto nati per tutelare i propri cittadini e beni, e che nemmeno la buona volontà dell’individuo può incidere su questi processi. Servono movimenti globali, capaci di criticare e modificare l’idea di progresso della civiltà moderna e capitalistica. Ma è dubbio che questi movimenti possano coincidere – come sostiene Ghosh – con le grandi religioni, che hanno in genere sottoscritto l’idea della centralità dell’uomo nel creato, poi ripresa dal liberalismo in chiave individualistica, e nonostante l’opera di riformatori come Francesco e Gandhi coesistono finora senza forti conflitti con il sistema economico dominante.
Secondo Jean Attali, in Breve storia del futuro, la sovranità degli Stati lascerà il passo a un governo del mercato, i cui interlocutori saranno individui sempre più isolati e marginali nella gestione del potere. Ma se le previsioni sui limiti della crescita economica e delle risorse naturali sono oggettive, quelle su chi e come governerà i processi globali sono molto incerte. Quel che è sicuro è che il futuro dipenderà molto da quanto la disponibilità della conoscenza permetterà la formazione di comunità transnazionali, capaci di contrapporsi alla tendenza degli stati a difendere la propria nicchia con la forza e di diffondere nuovi modelli di vita e di società sostenibile. In altre parole, non basta dire che il mondo non ci appartiene, e magari sognare un ritorno alle società premoderne in nome di un’ecologia utopistica. Bisogna piuttosto riconoscere e diffondere l’accesso al bene della conoscenza, e dunque difendere e sostenere l’istruzione di massa, riconoscendo che è anch’essa un bene minacciato e precario. La conoscenza del fatto che il modello economico in cui viviamo è destinato a autodistruggersi è già abbastanza salda; si tratta di rendere accessibile questa verità e distinguerla dalle altre narrazioni che influenzano gli individui. Mi pare quindi che la conoscenza scientifica e la capacità di interpretare criticamente queste narrazioni sia l’unica fonte di speranza nel fatto che l’umanità non soccomba ai meccanismi globali che ha innescato, a partire dall’illusione di possedere il mondo.
Sumaya Abdel Qader – politica, consigliera comunale di Milano
A chi appartiene il mondo? Una domanda che l’essere umano si è posto dalla notte dei tempi, in contesti differenti, sviluppando riflessioni e risposte uniche e irripetibili. Così il mondo è stato attribuito a diversi soggetti che ne divenivano esclusivi proprietari, promulgatori di regole, valori e principi: a Dio, agli dei, ai ricchi e ai potenti, a madre natura, ai re e alle regine, a nessuno, eccetera.
Nel pormi la domanda, da credente, la prima risposta che mi sovviene tra le tante è che “il mondo appartiene a Dio, ma…”. Nell’Islam il Creato è frutto della volontà divina, poi messo a disposizione dell’uomo che lo prende in carico e ne diventa custode. Volendo dare una lettura “laica” possiamo estrapolare l’idea dal suo senso prettamente religioso e ragionare su un concetto che merita attenzione: il mondo non è nostro ma noi ne siamo “custodi”. Ciò implica che non ci sia qualcosa da possedere ma una responsabilità da condividere. Dando questa lettura si apre una prospettiva, non più legata appunto al concetto di possesso (che implica spesso egoismo, accentramento di potere, esclusività, gerarchia, arbitrarietà, ecc.) ma alla consapevolezza di sé come essere verso l’altro, dove questo altro può essere l’ambiente, l’umanità e tutto ciò che non siamo noi ma che da noi, appunto, parte.
Se decidiamo che non si parla più di possedere il mondo ma di custodirlo veniamo individualmente coinvolti in un articolato sistema che mette in relazione e interdipendenza persone, animali, ambiente e cose immateriali. Non siamo indipendenti, dunque, ma dipendenti l’uno dall’altro. Non siamo liberi di far ciò che ci va ma dobbiamo fare ciò che non procura danno. Tenere l’equilibrio tra le diverse direzioni è la grande difficoltà che sfida in particolar modo gli individui delle società sempre più avanzate, consapevoli della necessità di vivere in modo sostenibile, eco e human friendly. È chiaro che per “mondo” non va solo inteso un sistema immenso e astratto. Il mondo è la nostra casa, la via sottostante, il nostro quartiere, la nostra città. Se ognuno di noi avesse cura del suo “piccolo mondo” il più ampio sistema ne gioverebbe, e non poco.
In generale, poi, se si considera una lettura in chiave ecologica è chiaro come funzioni ad oggi l’approccio dell’uomo verso tale mondo: l’ecosistema umano, per crescere, distrugge altri ecosistemi. Così, il futuro che ci aspetta non pare migliore del presente o del passato: si prospetta l’aumento della siccità, l’aumento delle carestie, l’aumento di calamità naturali, il tutto accompagnato dalla inevitabile crescita del numero dei profughi ambientali, del cambiamento degli equilibri ambientali/ecologici; per non parlare dei profughi di guerra, dei rifugiati politici, dei migranti economici. È inevitabile pensare che ci sia sempre più bisogno di riadattare stili di vita, abitudini, mentalità, attraverso nuove forme di resilienza. Essere custodi del mondo e non padroni si scontra però con l’atteggiamento “razionale-egoistico” dell’essere umano. Se non si supera una certa soglia minima globale di atteggiamenti, abitudini, scelte, strutture mentali, eccetera, volti ad essere responsabili e solidali, a poco serviranno gli sforzi dei “custodi”. Serve una rivoluzione interiore che ci porti ad essere verso l’altro.
Graziano Graziani – giornalista culturale
Il mondo, da sempre, è di chi se lo prende. La storia del colonialismo europeo lo ha insegnato in modo drammatico: non c’è crimine contro i principi di libertà, eguaglianza e fraternità tra i popoli che non sia stato perpetrato in nome del profitto e del dominio da quelle stesse nazioni europee che quegli stessi principi hanno ideato o contribuito a definire. Oggi quello spirito predatorio si è spostato in campo finanziario – anche se le guerre in medioriente ci ricordano che lo strumento dei conflitti è stato bandito sì, ma solo per quanto riguarda gli stati occidentali, aspetto a cui si richiama la logica del terrorismo di “portare la guerra in casa” nostra. Questa metamorfosi ha prodotto una serie di contraddizioni: da un lato merci e flussi turistici si muovono con sempre maggiore facilità tra gli stati, dall’altro si costruiscono barriere fisiche, nuovi muri, per arginare le ondate migratorie; da una parte l’Europa e gli stati occidentali restano baluardi delle libertà democratiche e individuali, almeno al loro interno, dall’altra in campo economico sono spesso partecipi di quei processi che innescano le migrazioni e hanno l’effetto di scuotere alle fondamenta quegli stessi principi e libertà.
Il drammaturgo rumeno Matei Visniec, nel suo testo «Occidental Express», tratteggia un personaggio cieco, vissuto tutta la vita nell’Europa comunista, che passa la vecchiaia viaggiando per le vecchie frontiere europee per il solo gusto di pisciarci sopra. Questa storia picaresca racconta molto bene del senso di liberazione che si è innescato all’indomani del crollo del muro di Berlino. Oggi è evidente che il modo in cui immagineremo i confini nel prossimo futuro ci rivelerà di chi è davvero il mondo. Perché dall’utopia dell’universalismo dei principi delle democrazie occidentali stiamo passando all’immaginario distopico della fortezza assediata, dove chi è dentro gode di determinati privilegi e chi è fuori preme per entrare.
Mi rendo conto che questo ragionamento è sbilanciato, nello sguardo, sulla prospettiva occidentale e pecca di quello che gli antropologi chiamavano “eurocentrismo”. Ma l’immaginario della fortezza, in realtà, appartiene anche alle emergenti economie come il Brasile e la Cina, dove il divario tra poveri e ricchi genera situazioni di segregazione al pari di quelle che cerca di edificare l’Europa, e forse anche più estreme. Nel mondo globalizzato e interculturale che abita un pezzo della popolazione mondiale non è più il colore della pelle a fare la differenza tra chi è incluso e chi è escluso dai privilegi (anche se recrudescenze razziste sono sempre dietro l’angolo), ma il livello di ricchezza. Chi è povero ne è escluso e ne sarà sempre più escluso, visto che gli ascensori sociali disegnati nel Novecento sembrano essersi bloccati. Emergerà chi sarà in grado di sviluppare un sapere tecnico scientifico tale da essere indispensabile ai processi di sviluppo tecnologico, oppure chi saprà assecondare le logiche dello spettacolo ritagliandosi un ruolo nel mondo dell’intrattenimento. Ma entrambe le strade sembrano parecchio distanti dal criterio di un progressivo miglioramento sociale dell’intera popolazione.
Un altro tema centrale è quello del lavoro, che non è in crisi solamente perché la curva della crescita non può essere in perenne crescita, ma anche perché molti dei lavori che conosciamo oggi saranno spazzati via dall’automazione. Questa possibilità, data per certa da molti analisti, crea un cortocircuito tra la ricerca del profitto e dell’efficienza, di matrice liberale, e l’utopia della liberazione dal lavoro, di matrice socialista, tanto che una delle proposte più strutturate di “reddito universale di cittadinanza” viene dal capitalismo tecnologico della Silicon Valley, ovvero da persone come Bill Gates, Marc Zuckerberg ed Elon Musk. Gli ottimisti intravedono in questa prospettiva un’idea di emancipazione dell’uomo, mentre i pessimisti scommettono che la totale dipendenza dal sistema sarà il cappio definitivo posto al collo delle masse popolari, la metamorfosi completa e irreversibile dello status di “cittadino” in quello di “consumatore”. Quale che sia la prospettiva più corretta, è chiaro che in questo contesto definire cosa sia la “cittadinanza” e a chi spetti – anche alla luce della “fortezza assediata” a cui si accennava prima – sarà lo strumento che disegnerà l’utopia o la distopia dell’immediato futuro.
Ed è altrettanto chiaro che le tecnologie giocheranno un ruolo fondamentale. Cosa che apre degli interrogativi che si riflettono sull’ultima parte della domanda che è stata posta: chi si deve prendere cura del mondo? E come? Yuval Noah Harari, nel suo best seller «Sapiens», ci ha ricordato come la prima vera colonizzazione sia stata quella della specie homo sul pianeta e come questo processo storico sia costato l’estinzione di migliaia di altre specie parecchi secoli prima che fosse necessario formulare l’idea di “inquinamento”. Oggi, che i sapiens si sono moltiplicati fino alla cifra stratosferica di sette miliardi di individui, hanno sviluppato tecnologie inimmaginabili solo pochi secoli fa che gli danno un enorme potere sulla natura; per di più, si sono liberati dei vincoli morali delle religioni e dei loro codici di comportamento. Ci troviamo di fronte a una specie che ha assunto per la prima volta nella storia del mondo una capacità di influire su di esso e modificarlo pari a quella degli antichi dei (e difatti il saggio successivo di Harari si intitolo «Homo deus»). Uno scenario del genere, necessariamente, apre a scenari inquietanti che spostano sempre di più il dibattito pubblico sulla frattura tra tecnoentusiasti e tecnoscettici. Se c’è un filo che tiene insieme cose sideralmente lontane tra loro come il radicalismo religioso, la contestazione di movimenti spontanei come i no vax o lo sviluppo di credenze che un tempo erano etichettate come new age, questo filo è il rifiuto dell’autorità scientifica. La quale, a sua volta, non è certo in grado da sola di fornire risposte a domande che sono principalmente culturali, che nascono dall’assenza di un orizzonte di senso in cui inserire queste magnifiche sorti e progressive che la tecnologia sta tracciando.
Ovviamente non è una questione di tifo. Come tutti gli strumenti inventati dall’uomo, anche quelli partoriti dallo sviluppo tecnologico possono essere occasioni meravigliose o armi, più o meno improprie, di un conflitto che si gioca non più soltanto sulla nostra pelle ma su quella dell’intero pianeta. Di fronte a queste possibilità estreme, un atteggiamento che mi sembra sensato è quello di Roberto Cingolani, direttore dell’Istituto Italiano di Tecnologia. Intervistato dal direttore de Linkiesta Francesco Cancellato, ha dato una definizione di scienziato che contiene, a mio avviso, un approccio plausibile ai problemi che interesseranno il mondo nel prossimo futuro e che lo interessano già oggi: “[Lo scienziato] È uno che per mestiere mette toppe ai buchi che hanno creato quelli che sono venuti prima, in un contesto di distruzione irreversibile del pianeta. Io devo solo sperare che le toppe che metto oggi facciano meno danni rispetto a quelle che ambisco di riparare. Faccio un esempio: settant’anni fa la plastica ha risolto un mare di problemi ma tra qualche anno ci sarà più massa plastica che pesci in mare. Non esiste tecnologia che non sia una toppa”.