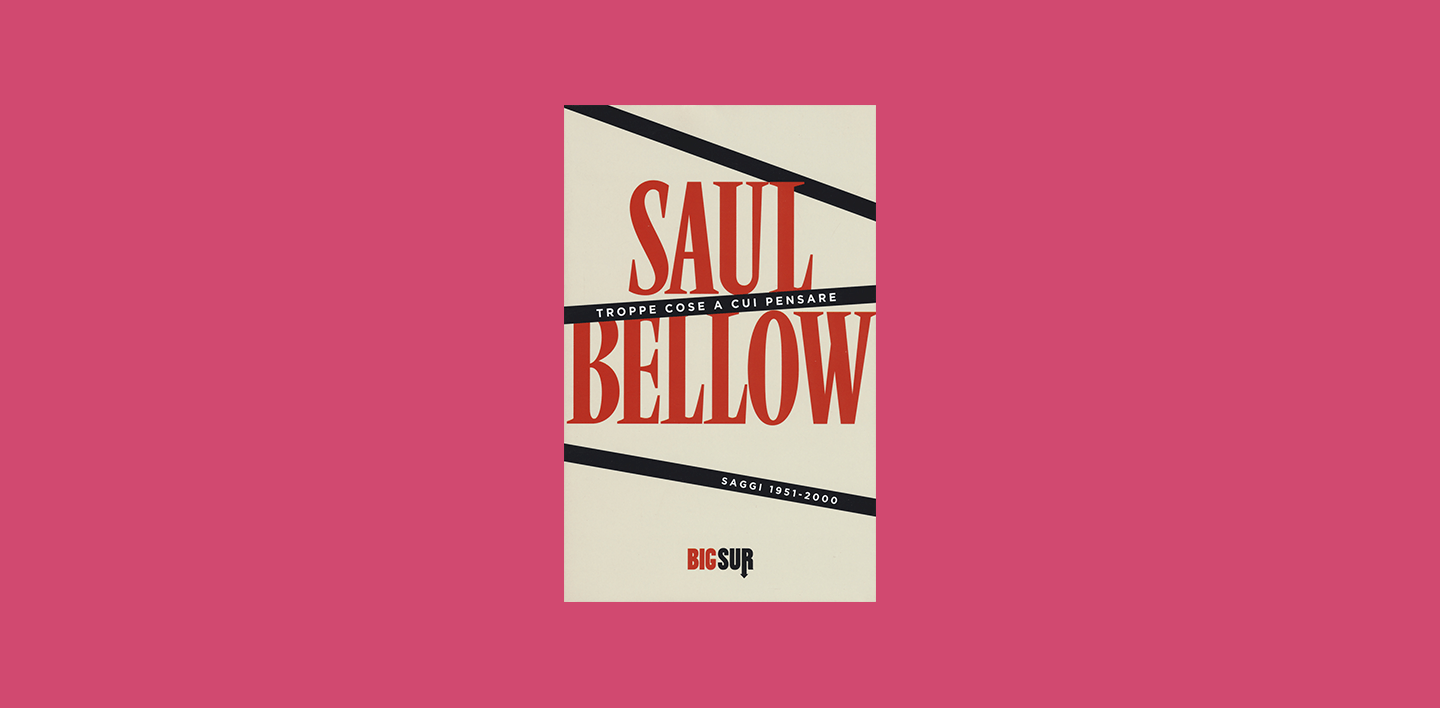
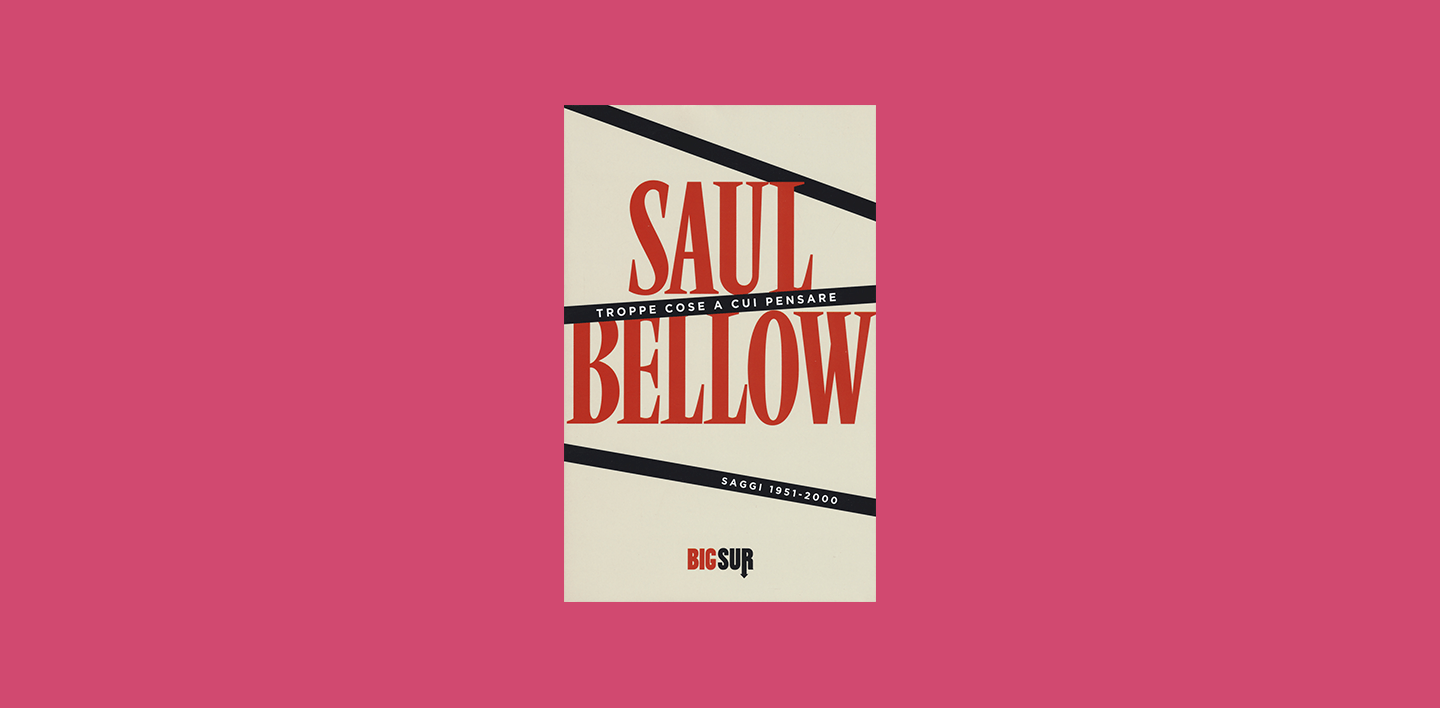
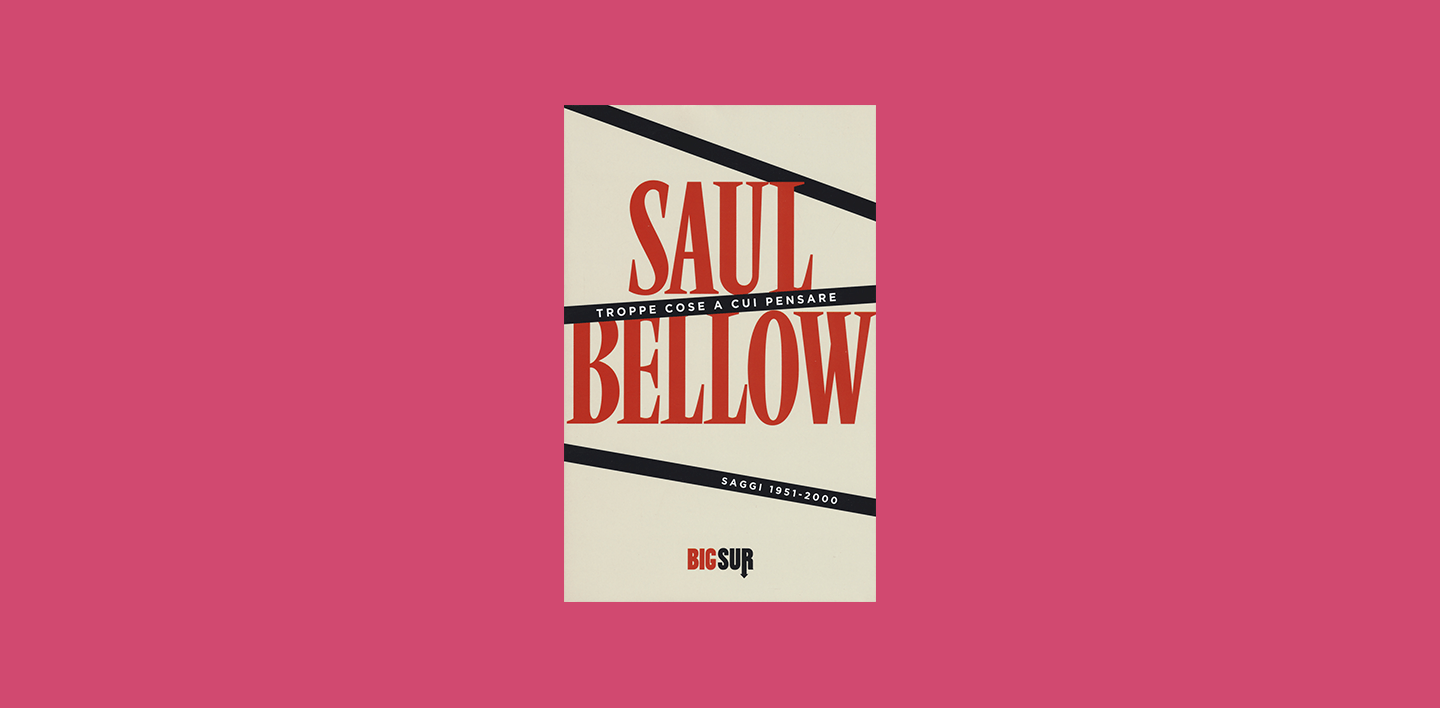
N el discorso di premiazione del Nobel per la letteratura, un mese fa, Kazuo Ishiguro, oltre a riconoscere dentro di sé e nella sua scrittura tracce di Charlotte Brontë, Kafka, Proust, ha confessato di sentirsi un impostore, che i vicini, avendo visto una coda di giornalisti davanti alla sua casa, dovevano averlo scambiato per un serial killer, che se l’avesse saputo si sarebbe lavato i capelli. Nel 2014 Patrick Modiano, visibilmente emozionato, non ha fatto altro che ringraziare i suoi lettori, che con il loro sguardo avevano dato vita alle sue storie, come quando si sviluppano i negativi nella camera oscura. E così Saul Bellow, nel 1976, senza nascondere un po’ di paura per i cambiamenti, per le cadute che la Storia ogni tanto ci riserva, per il tempo che passa e non vuole fermarsi, sembrava convinto che nonostante il frastuono, il rumore assordante della realtà, i libri continuassero a essere scritti e letti, che esistesse ancora, da qualche parte nel mondo, un lettore che lo stava aspettando.
Lo stesso spirito di quel discorso, la stessa umanità, che Bellow aveva trasmesso anche ai suoi personaggi, dal vagabondo Augie March all’isolato Herzog, sognatori, come lui cresciuti a Chicago, viene fuori anche quando si confronta con il genere saggistico. Leggendo Troppe cose a cui pensare. Saggi 1951-2000 (edizione italiana a cura di Luca Briasco, pp. 356, 20 euro), appena pubblicato da SUR, si nota come Bellow, negli anni, pur avendo raggiunto il grande pubblico, vincendo premi dal National Book Award al Nobel, sia rimasto sempre quello che andava in biblioteca a leggere le poesie di Sherwood Anderson e di Edgar Lee Masters, che scriveva seduto a un tavolino da bridge nascosto in una stanza nella casa dei suoceri, che amava “le cose grandi”. Senza provare angosce dell’influenza alla Bloom, estasi alla Lethem, senza troppe regole, insomma, secondo Bellow, l’importante è “assecondare l’istinto che presiede alla letteratura”, sia quando si legge che quando si scrive, e affidarsi alla propria esperienza.
Come Calvino, che non riusciva a spiegarsi perché nelle università non avessero ancora capito che “nessun libro che parla d’un libro dice più del libro in questione”, come Sartre, che definiva i critici “custodi di cimiteri” incapaci di provare emozioni, Bellow, che non smetteva mai di stupirsi del successo che avevano avuto i suoi libri, vedeva nella critica letteraria una visione limitata e limitante delle cose, fatta di etichette, movimenti e generi, e credeva che il mestiere del critico somigliasse a quello di “un sordo che fa l’accordatore di pianoforti”. Anche lui si prestava a scrivere di, ogni tanto, ma con gli occhi puri e incontaminati del lettore, che non smette mai di essere curioso, di imparare, di scoprire nuovi mondi, di farsi delle domande. Un lettore che scrive, quindi, che cerca solo di interpretare il mondo, di raccontarlo, senza avere mai la certezza di riuscirci. Credeva che i lettori “profondi”, quelli per cui le cose non sono mai “ciò che sembrano”, fossero quelli meno sicuri di sé, e non capiva come potessero preferire “il significato alla forza dei sentimenti”.
La bellezza del libro non vi potrà sfuggire, qualunque genere di lettore voi siate, ed è meglio accostarsi a un’opera d’arte con ingenuità, piuttosto che da idolatri della cultura, sofisticati e snob.
In Hemingway vedeva una “disperata devozione” nei confronti di sé, una “primitivizzazione”, la ricerca di costruire archetipi che potessero rimanere nel tempo, una vita vissuta in continuo movimento con la paura di seguire i processi dell’immaginazione. L’individuo moderno, secondo Bellow, nasceva nei Saggi di Montaigne, che a differenza di Sant’Agostino aveva avuto il merito di riportarlo sulla terra in tutta la sua fragilità. A Philip Roth, invece, riconosceva il merito di aver portato fin da subito la “narrativa ebraica” su orizzonti più ampi, sui beni materiali, ad esempio, come i sobborghi, i country club, le raccolte fondi per la lotta al cancro, le automobili, le pellicce, i gioielli, sulle cose che in fondo contrastano “la vita dello spirito”.
Bellow non concepiva i libri al di fuori della vita, anche quando aveva a che fare con le pagine bianche o con quelle che erano state già riempite da altri, continuava a guardarsi intorno, ad alzare lo sguardo, a interrogarsi sul presente e su quello che poteva ancora accadere. Come succede con autori come Vonnegut, Cercas, Cortázar, Pennac, Hamid, Calvino, i saggi di Bellow si leggono come fossero romanzi, scritti da chi sa che non c’è alcun bisogno di ostentare quello che sappiamo, di essere snob, che la letteratura, in fondo, è qualcosa che somiglia tanto alla vita. Il rischio di distrarsi c’è sempre, di avere “troppe cose a cui pensare”, anche in un mondo che è ancora lontano dal binge-watching e dai social network, dove però già spopolano i talk show e anche gli scrittori sono costretti a dire sempre la loro, ad avere un’opinione su tutto.
Quando mi chiedono un’opinione su alcune questioni particolarmente complesse dei nostri tempi, a volte rispondo dichiarando che sono a favore delle cose buone, e contro quelle cattive. Non tutti trovano la battuta divertente. Molti ne deducono che mi considero troppo buono per questo mondo che, senza alcun dubbio, è un mondo dominato dalle questioni pubbliche.
La tivù fa rumore, lampeggia, prende colore, ci invita a comprare, pretende la nostra attenzione, il nostro tempo libero. Qualcuno parla di bisogni primari, di utilità, di quello di cui abbiamo bisogno per sopravvivere. Starà allo scrittore rimettere un po’ di ordine, farci riscoprire cos’è davvero reale e importante, le vere occasioni di sofferenza, o di felicità.