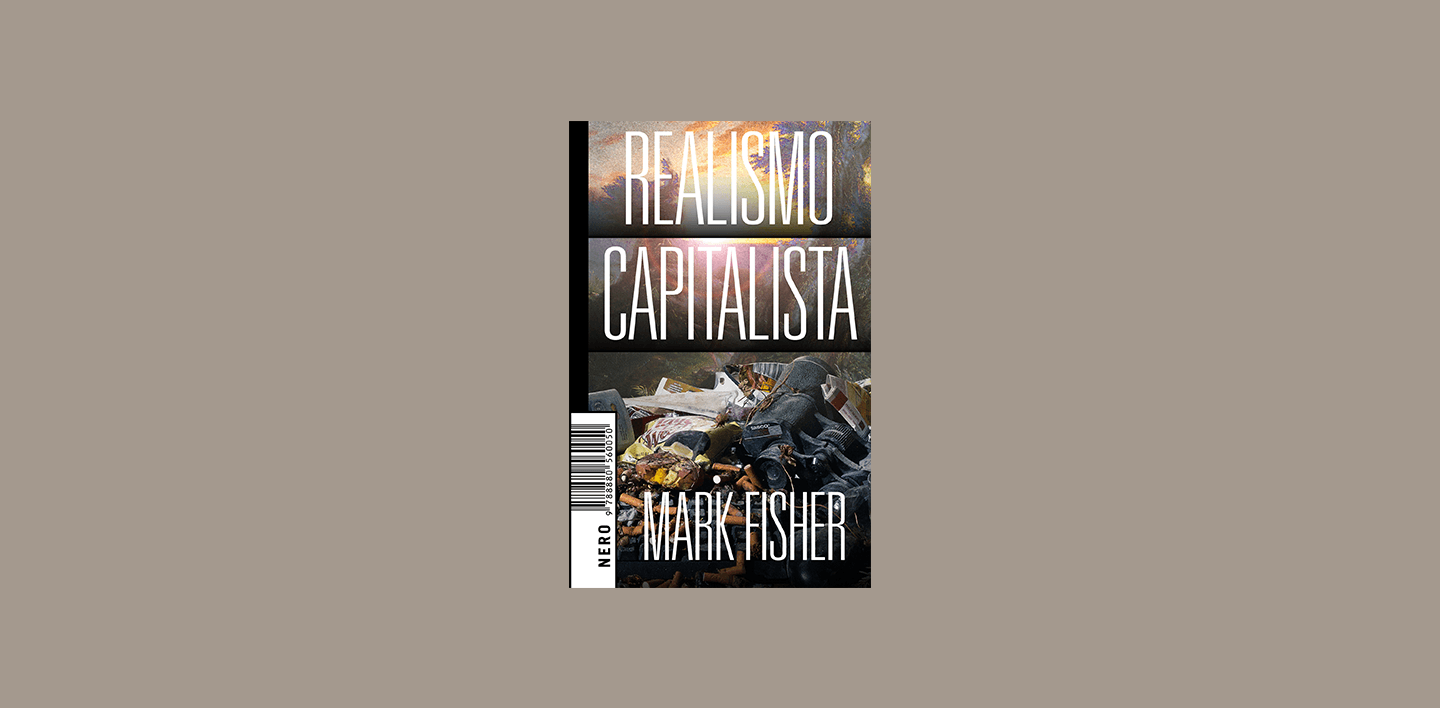
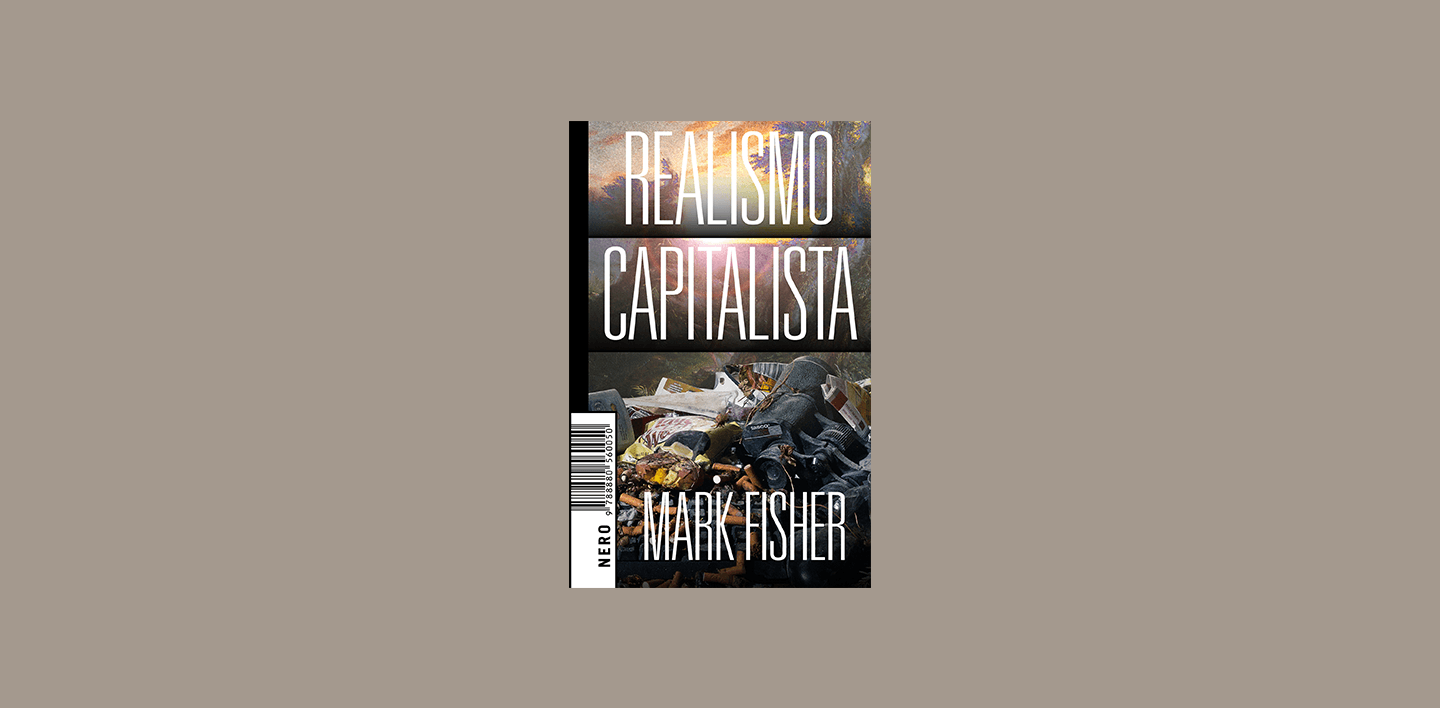
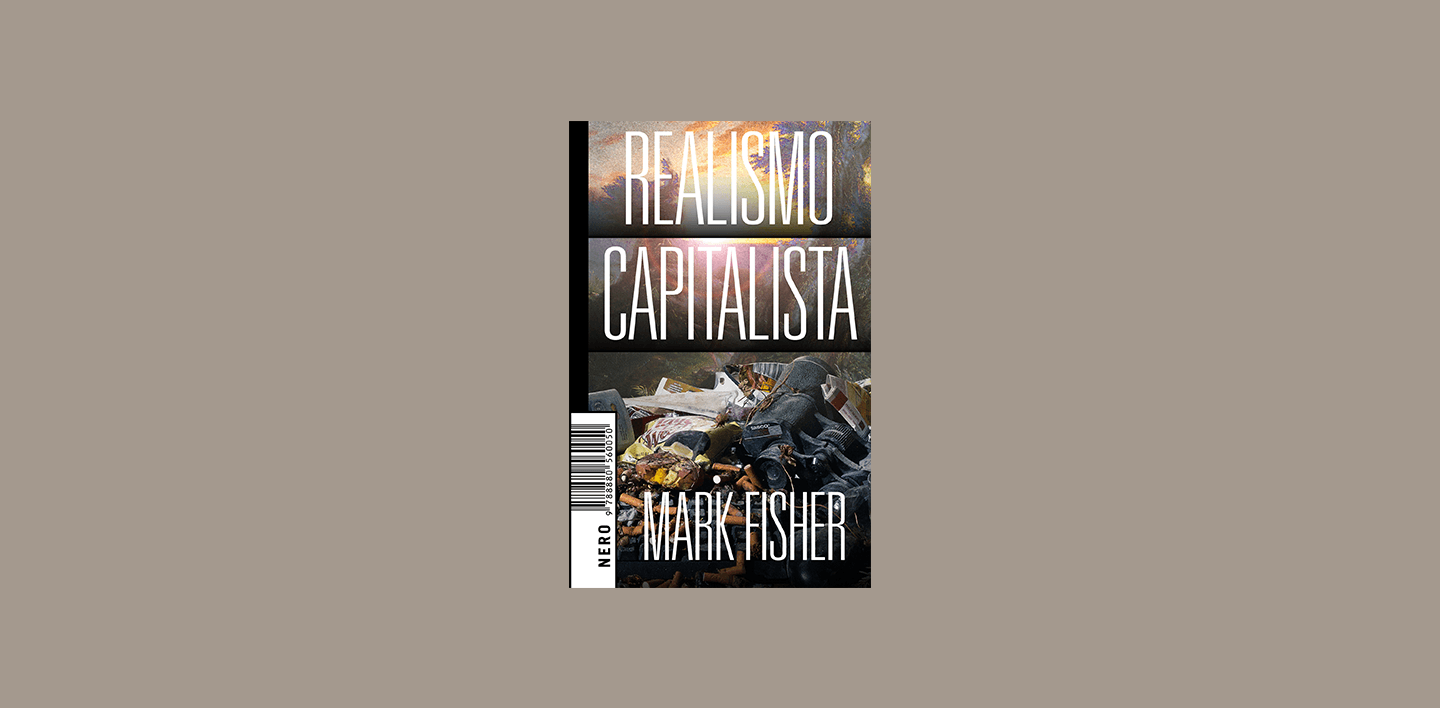
P rima di affrontare Realismo Capitalista di Mark Fisher è utile ricordare la data di uscita dell’edizione originale: 27 novembre 2009. Lo è per la sua prossimità alla grande crisi del 2008 quando esplosero, “non già con uno schianto ma con un lamento”, le contraddizioni dell’Internazionale Capitalista covate in seno alla svolta liberista degli anni ‘80, cullate dal laissez faire post-ideologico dei ‘90 e nutrite a steroidi dall’isteria finanziaria dei primi 2000. Lo è perché, col senno del 2018, non si può cogliere appieno il ruolo che ebbe questo testo, breve e incisivo, immediatamente molto letto e discusso, nel reintrodurre nel bagaglio intellettuale della sinistra inglese autori marginalizzati dal clima culturale post-blairismo: dall’ovvio Marx al meno ovvio Kafka, fino ai vari Deleuze, Foucault e Jameson.
Dopo una iniziale militanza nell’ormai famigerata e influentissima CCRU di Nick Land e Sadie Plant, dalla metà dei ’90 Mark Fisher si era affermato come critico musicale e teorico di cultura pop. Scriveva su magazine e quotidiani come The Wire e Guardian ma, soprattutto, su un suo blog personale, K-Punk: un punto di riferimento per chiunque volesse approfondire le direzioni in cui stava andando la musica e la cultura inglese. Imbattendosi in quel blog si coglieva subito che “giornalista musicale” era una etichetta che a Fisher calzava stretta, tale era la sua sensibilità nel decifrare la semiotica della cultura pop britannica per intarsiare discorsi altri intorno alle mutazioni della società inglese e, più in generale, occidentale.
Superata da poco la soglia dei quarant’anni, Fisher decise di ordinare gli spunti sotterranei ai suoi interventi su K-Punk in un primo libro che è proprio questo Realismo Capitalista. Uscito, come detto, nel 2009, il testo fu subito colto da un successo inatteso, oltremanica e non solo. Un successo che sorprese per primo Fisher e gli cucì addosso la veste di intellettuale di riferimento per un certo discorso sul contemporaneo. Un successo che rende ancora più inspiegabili i motivi per cui l’Italia ha dovuto attendere un nuovo editore coraggioso come NERO per riuscire infine a riceverlo.
La tesi fondamentale del libro è che l’espressione “realismo capitalista” è un buon modo di definire l’acqua in cui nuotano i nostri tempi, o come scrive lo stesso Fisher, la loro “atmosfera”. Mascherato da prassi operativa post-ideologica e puramente funzionale, secondo Fisher, il tardo-capitalismo è invece a tutti gli effetti un’ideologia a cui ci siamo assuefatti in nome appunto di un principio di realismo “più realista del re”. Con l’assuefazione è calata anche una rassegnazione tale per cui – come scrive anche Valerio Mattioli nella sua introduzione al testo – il “there’s no alternative” di tatcheriana memoria è stato introiettato così profondamente nell’inconscio delle società occidentali da diventare una specie di tara cognitiva, una sorta di Velo di Maya che ha mascherato come “fatto naturale” qualcosa che di “naturale” non aveva davvero molto: ovvero la resa incondizionata della politica di fronte agli imperativi logico-operativi del capitalismo, avvenuta dagli anni ’80 in poi. Ecco, in proposito, le parole di Fisher con, in coda, una bozza di strategia per uscire da questa impasse:
Inutile dire che quello che viene considerato «realistico», quello cioè che sembra plausibile dal punto di vista sociale, è innanzitutto determinato da una serie di decisioni politiche. Qualsiasi posizione ideologica non può affermare di aver raggiunto il suo traguardo finché non viene per così dire naturalizzata, e non può dirsi naturalizzata finché non viene percepita come principio anziché come fatto compiuto. Di conseguenza il neoliberismo ha cercato di eliminare la stessa categoria di principio, di valore nel senso etico della parola […] ha imposto con successo una specie di «ontologia imprenditoriale» per la quale è semplicemente ovvio che tutto, dalla salute all’educazione, andrebbe gestito come un’azienda. Come ricordato da tanti teorici radicali – siano essi Brecht, Foucault o Badiou – ogni politica di emancipazione deve puntare a distruggere l’apparenza dell’ordine naturale, deve rivelare che ciò che viene presentato come necessario e inevitabile altro non è che una contingenza.
Questa constatazione della natura ideologica e burocratica del capitalismo – poi non così diversa nella prassi e negli effetti sugli individui da quella portata avanti nel contesto del Grande Altro novecentesco del Capitale: il comunismo sovietico – non sarebbe in fondo nulla di nuovo rispetto a ciò che Deleuze e Guattari già scrivevano in Capitalismo e schizofrenia quando definivano il Capitale come “l’impasto informe di quanto è già stato” o la “cosa innominabile” che “informa” la Storia, o quando Jameson sosteneva che ormai è più semplice immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo. Quello che fa di Fisher un intellettuale in grado di aggiungere qualcosa rispetto alla tradizione post-strutturalista da cui si eleva, è la sua capacità di cogliere i sintomi della sindrome da “realismo capitalista” in molteplici direzioni.
La rileva nella diffusione di disturbi psichiatrici tra i giovanissimi; la nota nell’introduzione di un approccio para-cibernetico nel rapporto tra studenti e insegnanti all’interno del sistema educativo anglosassone; nella mitopoiesi di un “homo novus reaganianus” tracciata dal cinema e dalla letteratura noir americana a partire sempre dagli anni ’80; nella schizofrenia latente al rapporto tra i valori “slow” che il tardo-capitalismo sostiene di voler tutelare e anzi alimentare – in primis quelli della “famiglia” – e le prassi “smart” con cui in realtà li mina alle fondamenta; nel primato raggiunto nella sfera delle relazioni pubbliche dal “comunicazionale” rispetto all’”effettuale” (forse la mia frase preferita di questo libro è: “Mettiamola così: nel capitalismo tutto ciò che è solido si dissolve nelle public relations”); nei limiti intrinseci a un’analisi puramente quantitativa – post-informatica – dello stato di salute di una cultura e di una società. Un’approccio, quest’ultimo, che secondo Fisher è più che miope. È – citando nuovamente Deleuze e Guattari – proprio analfabeta.
La qualità più spiccata di Realismo Capitalista è insomma di agganciare un discorso teorico che altrimenti resterebbe estremamente rarefatto e para-accademico a fatti concreti e trasformazioni osservabili delle nostre società, a volte quasi banali, e di farlo con un’urgenza e un trasporto da cui traspira il tepore di una preoccupazione viva, umanissima e umanistica, per la zoppìa dei tempi. Un’urgenza e una sincerità viscerale che permettono a Fisher di muovere critiche anche severe ai suoi interlocutori più prossimi: uomini e donne di sinistra che, pur con tutte le buone intenzioni del mondo, nel 2009 vedeva asserragliati su due posizioni opposte, ugualmente fallaci e inefficaci. Da una parte l’immobilismo conservatore di chi vagheggiava un ritorno all’antico regime, a rapporti lavorativi e sindacali novecenteschi e ormai irreparabili. Dall’altra il comunismo liberale del capitalismo etico o supposto tale, che dal 2009 a oggi ha preso ancora più piede sulle ali della disruption tecnologica. Insomma, quel nuovismo “turbo-smart” che coincide in realtà con un’accettazione supina dell’esistente e sta alla base della retorica del lavoro flessibile e dello start-uppismo a tutti i costi, che – aggiungo qui una coloritura mia – spesso altro non è se non una forma di assistenzialismo succedaneo, elargito da settori finanziari anziché pubblici, per chi comincia sognando la Silicon Valley e finisce dietro il volante di una Uber.
Questo non significa che per il Fisher del 2009 non fosse imperativo per la sinistra e per il mondo intellettuale che guarda in quella direzione, “mettere in discussione l’appropriazione capitalista della categoria del nuovo”. Tuttavia, questo “nuovo” che Fisher aveva in mente era un “rinnovamento che non fosse un ritorno” e nemmeno un’adesione al realismo “iperreale” che il libro contribuì a denunciare. Cosa esattamente sostanziasse questo tipo di “nuovo”, da dove cominciare a pensare un “diverso futuro possibile”, nel 2009 Fisher non era ancora in grado di articolarlo del tutto. Lo farà in parte in seguito, in altri testi successivi. E lo faranno, lo hanno fatto, lo stanno facendo per lui, insieme a lui, a partire da lui e da questo suo libro, altri intellettuali contemporanei, inglesi e non solo, in quello che è uno dei dibattiti intellettuali più appassionanti e cruciali dei nostri tempi. Un dibattito che senza questo libro sarebbe stato meno ricco e al quale, dal 17 gennaio 2017, manca moltissimo la voce di Mark Fisher.