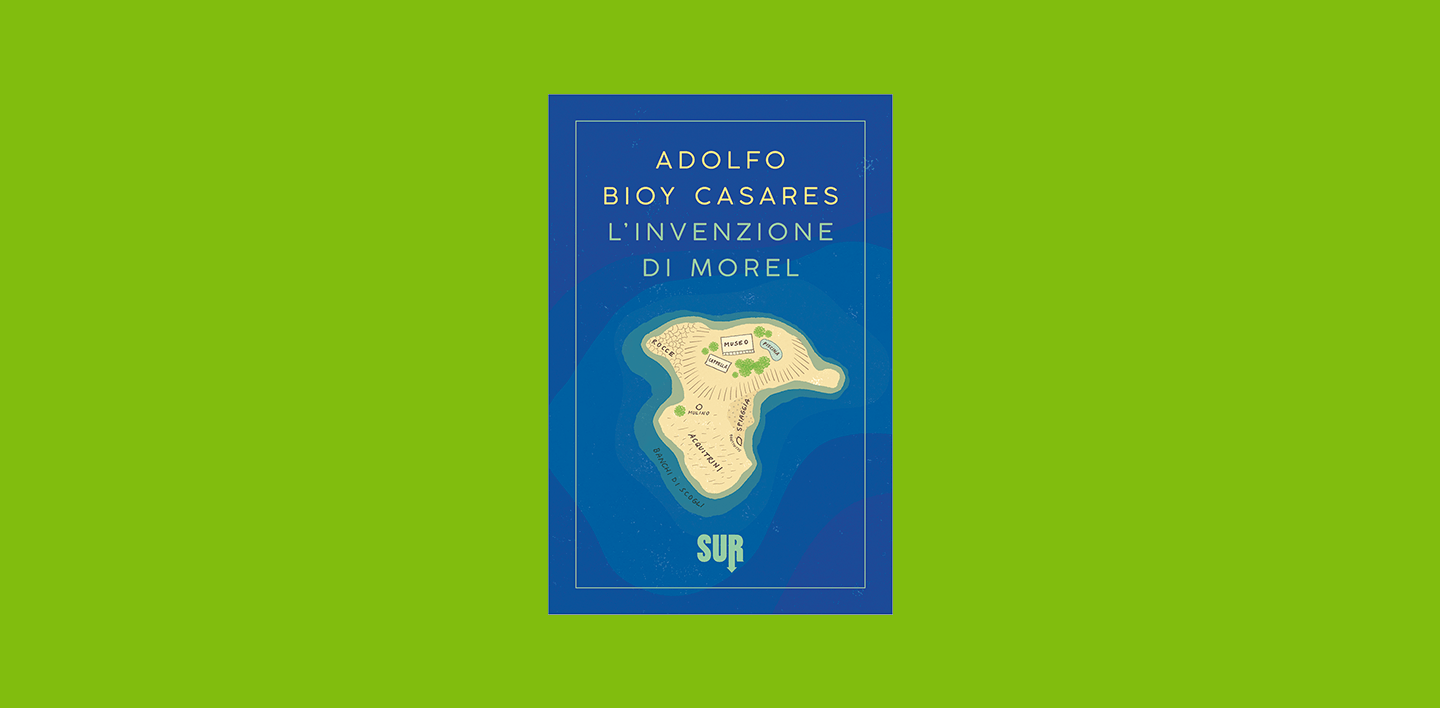
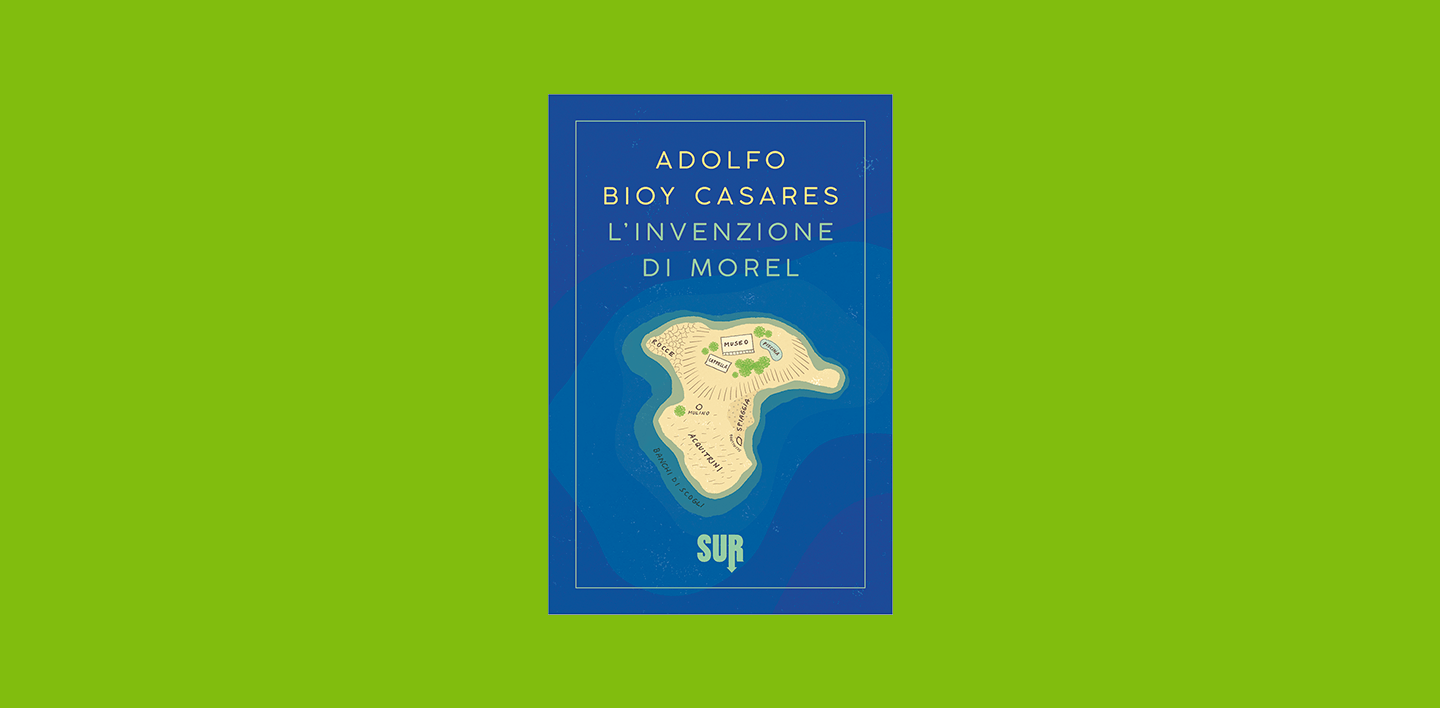
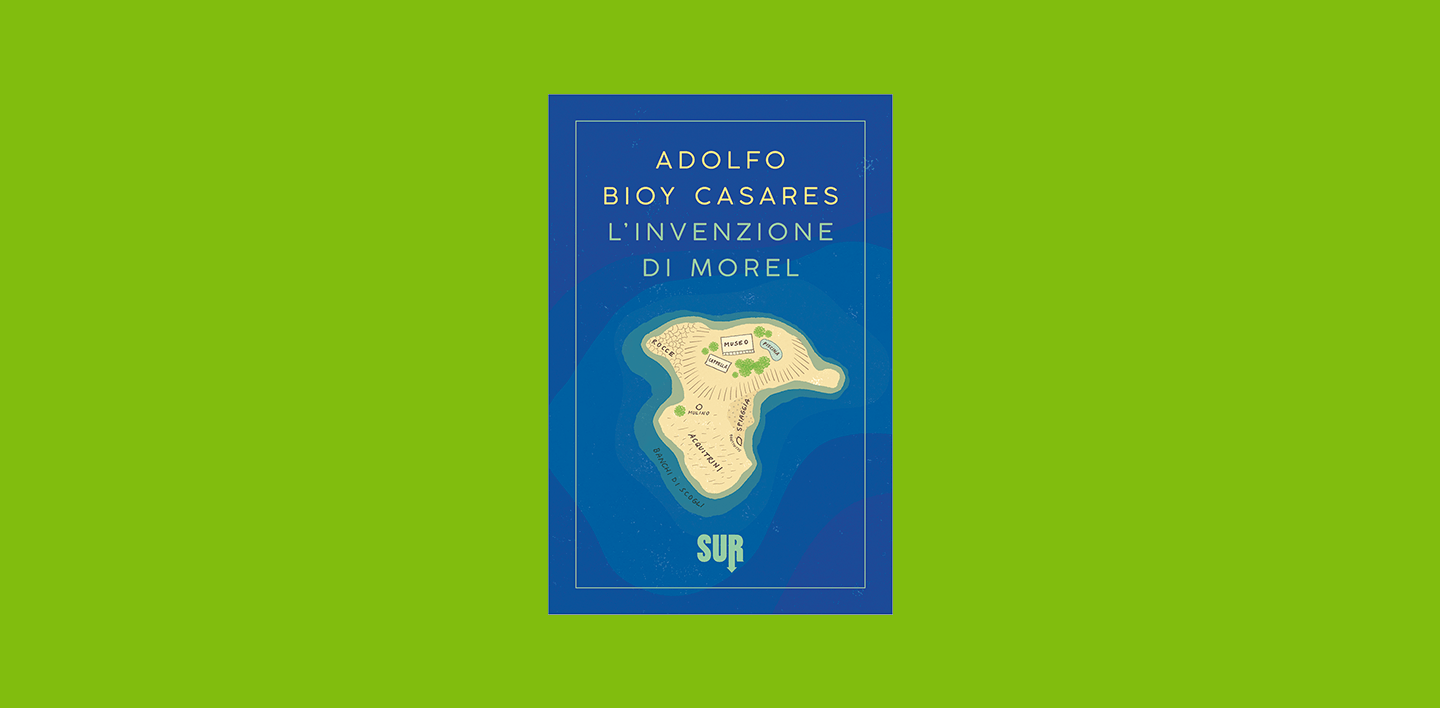
G ià grazie alla lettura infantile di un Robinson Crusoe ridotto ad usum delphini da qualche piccola casa editrice nasceva la seduzione dell’isola abbandonata. Poi, l’infinita schiera dei racconti dell’isola, dai classici greci e latini a Rabelais e Shakespeare, le isole dell’utopia e della fantascienza, isole ricorsive nel ciclo arturiano, nelle Mille e una notte, aggiornate alla moda di ogni secolo per arrivare poi ad altri Arturo, ad altri Crusoe.
Il Crusoe dell’Invenzione di Morel non ha nome, lo chiamerò il Naufrago. Il Naufrago è un anti-Crusoe, un sopravvissuto che non sa rimediarsi da mangiare – si ciba di radici, non sa leggere l’ambiente e non è interessato a raccogliere, accumulare e archiviare i suoi beni. Marea dopo marea, si inizia gradualmente ai misteri dell’isola: la desolazione del paesaggio viene rotta da una villa, anzi un museo, e una piscina dove si ingrumano vipere, rospi, rane e “insetti acquatici”.
Intorno alla villa, lungo la piscina e verso il promontorio, un gruppo di villeggianti (“uomini veri, veri almeno quanto me”) chiacchierano svogliati, prima ballano, poi si abbronzano, lontani da ogni preoccupazione. Nonostante si tenga inizialmente a distanza – potrebbero scoprirlo – il Naufrago si innamora di Faustine, “una donna che tutte le sere guarda il tramonto”, e comincia a tramare un cautissimo approccio. Peccato che Faustine, letteralmente, non lo senta, non lo veda: la prima di una serie di anomalie che vedranno gli ospiti distesi accanto alla piscina sotto la pioggia, impegnati a ballare a qualsiasi ora e ripercorrere sempre gli stessi itinerari. Nel cielo poi, ci sono gli occhi di due soli e due lune.
Come da tradizione il Naufrago è un enigmista; segue piste cieche, falsi indizi, ogni sua scelta è la rifrazione di uno spaventoso confirmation bias. Bioy Casares ha costruito un’isola-ragno che già dalla prima pagina ha intrappolato il suo entomologo: ogni movimento del Naufrago stringe i fili che lo insaccano. Forse sull’isola c’è uno scienziato pazzo che gioca con una sua invenzione, forse quella coreografia è un balletto di ologrammi, forse il Naufrago è meno reale di loro… il lettore non può che assistere alla lenta e progressiva stretta del nodo scorsoio.
Incastrato a metà del secolo, il libro di Bioy Casares potrebbe essere considerato un compendio del Novecento in letteratura; anzi, di temi sbocciati nell’Ottocento e raccolti a secchiate nel secolo successivo: il protagonista colpevole di un crimine che ignora e (auto)giustiziato da carnefici che non capisce; lo spettro del Döppelganger e la crisi di identità; la riproduzione delle immagini da parte dell’uomo – chi viene ritratto invecchia impazzisce schiatta.
Freud scrive das Unheimliche, perturbante, nella Silicon Valley si direbbe uncanny, come la uncanny valley – l’area di dissonanza cognitiva che ci fa sembrare disumano un replicante. Questa uncanny island al largo del Pacifico è infestata dalle immagini e una di loro, Faustine, piega una storia d’amore in una storia di fantasmi (“forse abbiamo sempre voluto che la persona amata avesse un’esistenza di fantasma”). Figlia putativa di Circe e Calipso, Faustine è la ninfa e la strega: la sua indifferenza ultraterrena carbura le turbe del protagonista, perso in un carosello dove turbinano anime morte: “i morti continuano a stare fra i vivi.”
Bioy Casares riesce a inoculare un virus nel lettore – insistendo con il tedesco potremmo chiamarlo Fernweh, cioè la nostalgia di un posto in cui non si è mai stati o, allargando il campo, la nostalgia di persone che non si sono mai conosciute: tra i principali sintomi nel quadro patologico della Letteratura, questo dialogo perpetuo con i morti.
Le immagini mi spaventano, ma mi proteggono […] A chi servirà? A noi stessi, forse torneremo a vedere gli anni felici. Credevamo che la felicità di quegli anni potesse durare per sempre, invece tutto sta per finire. Tutto quello che è intorno è cambiato.
Tutto quello che è intorno è cambiato, come il mondo intorno ai protagonisti de La nube purpurea (Shiel, 1901) e Dissipatio H. G. (Morselli, 1973), segnalati da Michele Mari come asteroidi della stessa fascia. Scrive lo stesso Mari che quello di Bioy Casares è un romanzo
algido, geometrico, intimamente loico, popolato di araldici emblemi più ancora che di simboli, l’Invenzione di Morel ribadisce un’antica illusione degli umani: che a divenire immortali sia sufficiente conseguire la Forma: la Forma formata e compiuta, definitivamente sottratta dall’arte alla corruttibilità della vita.
Che il supporto sia una parete di Chauvet o il wall di Facebook, non finiremo mai di appiccicare in giro le nostre immagini mentali, e le immagini non finiranno mai di dissolversi. Non su un’isola ma in una prigione, fuor di metafora, Egon Schiele scriveva nel suo diario:
Nella condizione in cui mi trovo, sradicato con violenza dal mio terreno creativo, con dita tremanti inumidite nella mia saliva amara, mi sono messo a dipingere per non impazzire del tutto. Servendomi delle macchie nell’intonaco ho creato paesaggi e teste sulle pareti della cella, poi osservavo il loro lento asciugarsi fino a impallidire e sparire nella profondità del muro, come fatti sparire dall’invisibile potenza di una mano incantata.
Come per Schiele, pittore, la scrittura si rivelava l’ultima, deserta spiaggia livida, così per il Naufrago. L’unica “alternativa eternatrice”, dovesse fallire l’invenzione di Morel, è il libro che teniamo tra le mani; finché ci siamo certo, finché vengono proiettate le nostre immagini.