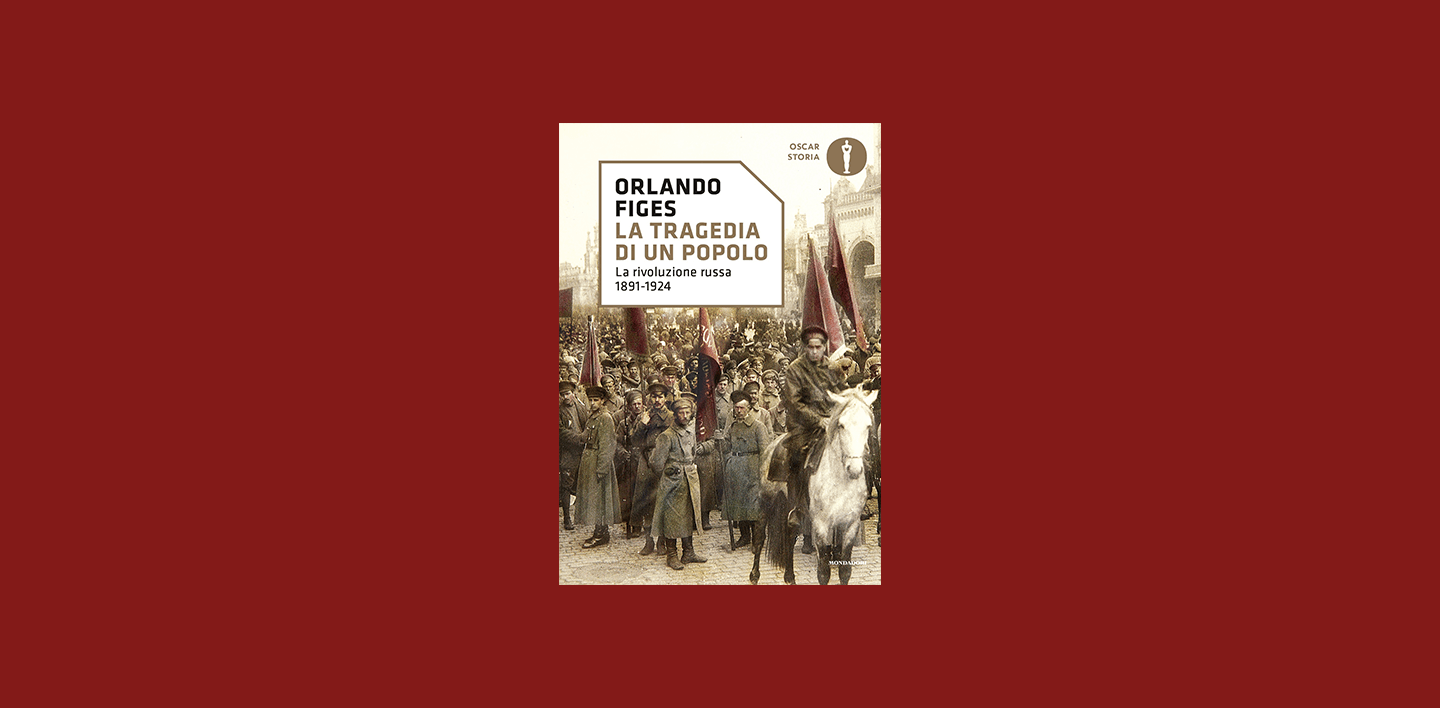
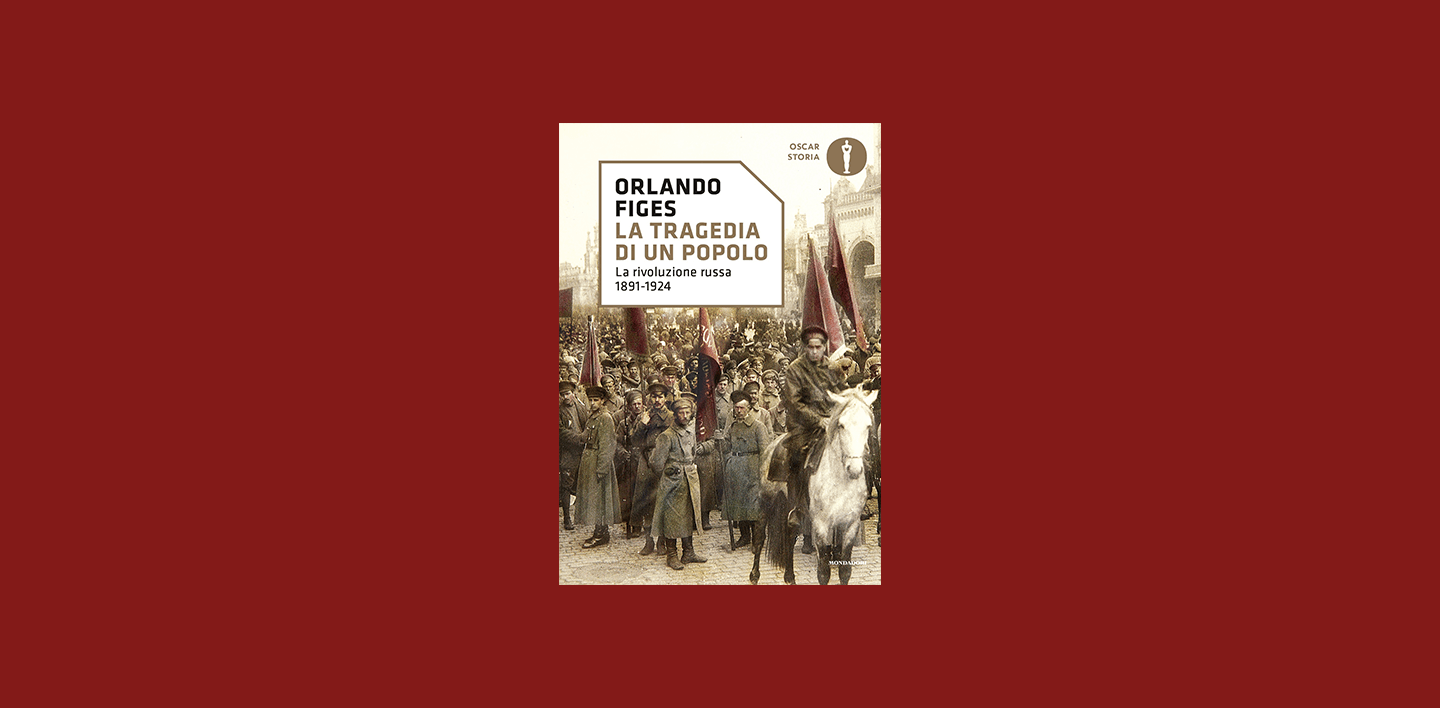
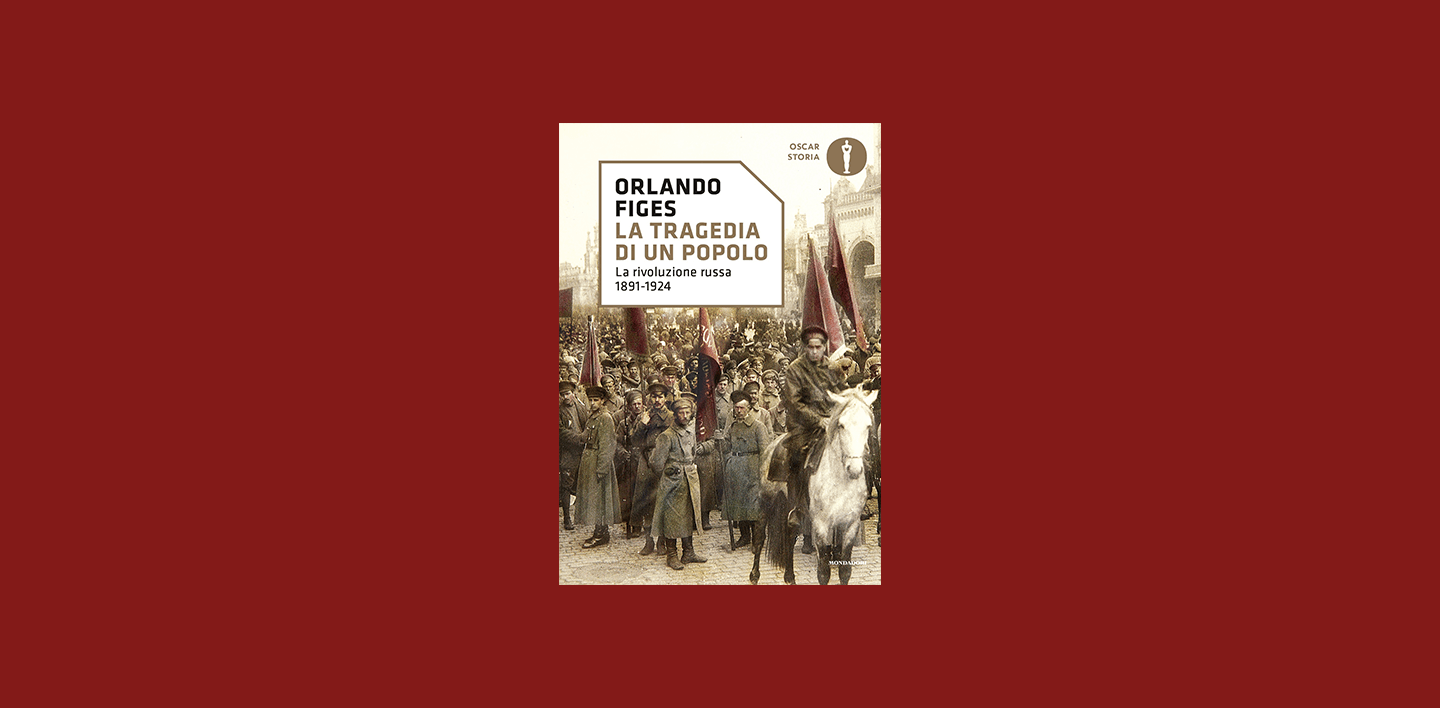
F ebbraio 1913, tutta la Russia è in festa. Lo zar Nicola II celebra il tricentenario del dominio della sua dinastia su un sesto delle terre emerse. San Pietroburgo è in ghingheri. “Le strade principali erano imbandierate e addobbate con i colori imperiali, il bianco, il rosso e il blu, le statue erano adorne di nastri e ghirlande e, sulle facciate delle banche e sulle vetrine dei negozi, spiccavano i ritratti degli zar a cominciare da quello del fondatore della dinastia, Michele. Ai fili delle tramvie erano stati intrecciati cordoncini di lampadine colorate che, a sera, s’accendevano a formare le parole ‘Dio salvi lo zar’g o a rappresentare l’aquila bicipite dei Romanov e le date 1613-1913.” Messe, spettacoli, fuochi d’artificio, giostre, concerti, balli: i festeggiamenti si protraggono per giorni, è una prova muscolare di ricchezza e potenza. Tre mesi dopo, la celebrazione continua; la famiglia imperiale intraprende un pellegrinaggio sui luoghi simbolo della dinastia. La partenza è a Kostroma sul Volga. Qui, al passaggio del battello imperiale, cittadini e campagnoli si affollano sulle rive. “Centinaia di entusiasti, pur di arrivare il più vicino possibile agli augusti visitatori, erano entrati in acqua fino alla cintola.”
La scelta di aprire con una vivida, sontuosa descrizione della festa dei Romanov il suo La tragedia di un popolo, monumentale saggio sulla rivoluzione russa di cui in questi mesi ricorre il centenario, dice già molto dello stile dello storico Orlando Figes. Inglese, classe 1959, docente al Birkbeck College di Londra, Figes è uno dei maggiori esperti mondiali di storia russa. Oltre allo studio sulla rivoluzione uscito vent’anni fa e di recente ripubblicato in Italia, la sua bibliografia spazia dalle vicende belliche (Crimea. L’ultima crociata) alle oscure esistenze delle vittime del terrore staliniano (Sospetto e silenzio) fino a cavare una storia d’amore dagli archivi del KGB (Qualcosa di più dell’amore) e a perlustrare i confini della cultura russa (La danza di Natasha).
A suo tempo uno dei maggiori storici del ‘900, Eric Hobsbawm, ha sostenuto che La tragedia di un popolo “è un libro che mette il lettore faccia a faccia con uno dei maggiori sconvolgimenti sociali della storia” e capace di aiutarci a capire la rivoluzione russa “più di ogni altro libro che io conosca”. Mentre Emmanuel Carrère, tra gli scrittori più brillanti della scena internazionale, ha esaltato le doti narrative (“des talents de romancier”) di Figes fino a prodursi in una dichiarazione d’amore intellettuale: “ho capito (è la legge dei colpi di fulmini letterari) che avrei letto tutto ciò che il suo autore aveva o avrebbe scritto”. Gli elogi incrociati di Hobsbawm e Carrère mettono in luce il doppio pregio di La tragedia di un popolo, un capolavoro di storiografia e narrazione.
La Storia
Come Tolstoj col ricevimento di Anna Pavlovna che apre Guerra e pace, Figes utilizza la festa dello zarismo per scaraventarci nel bel mezzo della storia russa. Qualche pagina dopo, tuttavia, è già pronto ad avvertire che l’evento è poco più che un’operazione di marketing politico. Dietro gli intrecci di luminarie e i banchetti le basi dell’impero mandano scricchiolii sinistri. Il farraginoso apparato burocratico, la nobiltà agraria in declino, l’esercito allo sfascio, una sconfinata popolazione rurale oltre la soglia della povertà: sono questi i fattori principali che rischiano di portare la Russia alla “catastrofe rivoluzionaria”. La prima crepa non va datata 1917 e neanche 1905 ma, secondo Figes, molto più indietro. È nel 1891, infatti, che una delle più devastanti carestie della storia russa crea due premesse essenziali allo scoppio della rivoluzione: nell’assenza di interventi efficaci dall’alto, la fede del popolo nello zar s’incrina e, grazie ad associazioni e istituzioni locali che fanno fronte al dramma umanitario, si animano le attività e il dibattito pubblico. Grosse fette di società russa si politicizzano e radicalizzano. Studenti e attivisti si convertono al marxismo.
Da qui in poi quella passata in rassegna in La tragedia di un popolo è la storia di una rincorsa verso la voragine e dei vari tentativi di evitarla. Come le pressioni del primo ministro Vitte perché Nicola trasformi la Russia in una moderna monarchia parlamentare che dia sfogo alle esigenze popolari. O la riforma agraria ideata da Stolypin, che puntava a creare una classe di coltivatori diretti forniti di diritti di rappresentanza che avrebbe disinnescato il malcontento delle masse contadine. L’esasperazione del momento è tutta nella figura dello zio dello zar granduca Nicolaj, che dopo il primo scoppio rivoluzionario del 1905, invitato da Nicola ad assumere l’incarico di dittatore per rimettere in riga il popolo, risponde con un gesto degno di un personaggio di Dostoevskij: estrae la pistola e minaccia, qualora il nipote non conceda le riforme, di uccidersi lì su due piedi.
Ma il saggio Vitte cade in disgrazia presso il sovrano. Le timide riforme concesse dallo zar col Manifesto d’Ottobre saranno presto indebolite. Stolypin si guadagna l’ostilità di quasi tutto il parlamento e, quando viene assassinato, è sepolta con lui anche la legge che avrebbe potuto cambiare il corso della storia russa. Come se non bastasse, arriva la Grande Guerra. Le infinite, estenuanti file per il pane (“Tutto ebbe inizio dal pane”) e il turbolento quartiere operaio di Vyborg fanno il resto. È il 23 febbraio 1917. Una settimana dopo Nicola II abdica. È l’uscita dei Romanov dall’incubo della storia.
Tuttavia, osserva Figes, il debole Governo Provvisorio scaturito dai moti di febbraio infila un errore dietro l’altro: continua a rinviare le elezioni dell’Assemblea Costituente che sola avrebbe potuto legittimarlo e che avrebbe trasformato la Russia in una democrazia adulta, mette da parte la questione della terra che avrebbe dato soddisfazione alla “marea contadina”, non tratta per l’uscita dalla guerra e, anzi, avvia una fallimentare offensiva sul fronte mettendosi contro interi reparti di un esercito stremato. Cambiano le coalizioni, altre rivolte esplodono. Quando il generale Kornilov ordina alle truppe di marciare su Pietrogrado, è accusato di tentato colpo di stato e la situazione precipita. Nel caos delle strade, delle campagne e delle province il potere del Governo Provvisorio si assottiglia di giorno in giorno, mentre il partito di minoranza e opposizione dei bolscevichi accresce la propria presa sul paese. La semplicità dei loro slogan – “Terra e pace”, “potere ai Soviet” – è in grado di farsi strada tra le sirene delle fabbriche e negli estremi lembi della campagna russa più dei cavilli amministrativi degli avversari al governo. E di fronte ai tentennamenti degli altri leader di partito (“gli Amleti del socialismo democratico” li ribattezza Figes) il furore decisionista di Lenin, il capo bolscevico da poco rientrato dall’esilio, ha la forza d’urto di una palla demolitrice.
Al punto che la famosa rivoluzione d’ottobre si consuma in sole ventuno ore e, a dispetto della successiva retorica sovietica, con poca partecipazione operaia e altrettanto poco spargimento di sangue. L’incrociatore Aurora spara a salve come segnale d’inizio dell’assalto. Teatri, ristoranti e tram funzionano regolarmente mentre gruppi di insorti si abbandonano all’alcol scoperto nelle cantine del Palazzo d’Inverno. Alla fine della giornata i danni al palazzo ammontano a un cornicione scheggiato e a una finestra infranta al terzo piano. Così come è una fiaba sovietica l’immagine di un Lenin libertario intenzionato a mettere a frutto il rovesciamento politico creando uno stato decentrato e liberale. La rivoluzione d’ottobre è un colpo di stato che consegna la Russia alla guida di un solo partito e, attraverso l’autoritarismo di Lenin prima e di Stalin poi, nelle mani di un solo uomo.
Talenti narrativi
Ma in cosa consistono “des talents de romancier” di Figes? Innanzitutto, le descrizioni. La festa dei Romanov, la fortezza di Pietro e Paolo, le carestie, le file per il pane: ogni volta che si trova a fare i conti con un luogo o un avvenimento significativo, Figes depone provvisoriamente il bisturi dell’analisi e impugna il pennello. Quelli che dipinge sono grandi scenari collettivi, rappresentazioni dal sapore epico in cui i materiali dello storico (libri, diari, lettere, interviste, opere d’arte) sono maneggiati con grande cura per immergere il lettore nel vivo dell’evento. Ma il nervo narrativo in La tragedia di un popolo sono senza dubbio i personaggi. Figes non si limita al compitino di aprire finestre biografiche su questa o quella figura storica, impilando date e curriculum, ma mette in piedi dei ritratti a tutto tondo in cui la descrizione fisica si salda a quella psicologica che a sua volta rende ragione del percorso del personaggio in chiave storica e politica.
Così nel profilo di Lenin la sua figura “tozza, con quella testa a uovo affetta da calvizie incipiente, gli occhietti penetranti” tradisce l’ascendenza mongola da parte di padre; dal ramo materno gli vengono invece elementi ebrei, svedesi e tedeschi. Una combinazione di ascendenti allogeni in cui si annida in parte il suo disprezzo per la Russia e l’abitudine ad affidare le faccende più delicate agli stranieri del partito. Per non dire degli anni passati da rampollo della nobiltà agraria nei possedimenti materni di Kokuškino. Da qui il poco conto in cui Lenin teneva i contadini: il processo per danni alla tenuta di famiglia che intentò contro alcuni agricoltori fa tutt’uno con la proposta politica di non intervento nella carestia del 1891, poiché alleviare le sofferenze dei contadini avrebbe allontanato la data della rivoluzione. Ecco perché per Figes l’estrazione patrizia di Lenin “contribuisce a spiegare anche la sua personalità dominatrice”. L’autoritarismo del capo bolscevico emerge nelle tappe della sua carriera politica (l’imposizione sui rivali interni al partito, le epurazioni e così via) non meno che da eventi marginali. Quando nel treno che l’avrebbe riportato in Russia
Lenin diede ordine che a tutti i non fumatori fosse rilasciato un lasciapassare di ‘prima classe’ perché avessero la priorità nell’uso della toilette rispetto ai fumatori, dotati di lasciapassare di ‘seconda classe’,
sappiamo già con quale granitica disciplina e volontà di potenza cavalcherà l’onda della storia russa. Quel treno, commenta Figes, “fu un modello precoce di dittatura leniniana”. Ma nella folla di primi attori e figuranti che si aggira nelle pagine di La tragedia di un popolo spicca Maksim Gor’kij. Lo scrittore e militante russo s’inabissa e riemerge costantemente nel flusso degli eventi ora come protagonista, ora nei panni del testimone e commentatore attraverso stralci di libri, lettere, diari. Rimasto orfano giovanissimo, Gor’kij vive nella casa del nonno, “un luogo di miseria, di crudeltà e colera”, e si dà alla raccolta di immondizia e ai furti di legname. Quindi rimpalla da un lavoro all’altro: lavapiatti, stivatore, guardiano, ciabattino, disegnatore di icone, garzone di forno. Al culmine della disperazione, tenta il suicidio. Eppure proprio in virtù della terribile giovinezza trascorsa spalla a spalla con gli esemplari più bassi dell’umanità russa, Gor’kij è l’esatto opposto dell’intelligencija che condurrà la rivoluzione, ideologi e politici difensori di un’idea astratta di popolo e ignoranti e sordi verso i reali problemi popolari. Anche per questo Gor’kij mantiene in politica una studiata equidistanza e acutezza di sguardo: è nemico del dispotismo zarista ma allo stesso tempo diffidente del dogmatismo bolscevico (“Non appartengo a nessuno dei nostri partiti e ne sono lieto”). Queste caratteristiche e la sua storia personale consentono a Figes di farne una specie di voce narrante in seconda, un Virgilio in salsa storiografica.
Ma la cura per i personaggi di Figes è anche nella scelta di dar voce ai più oscuri protagonisti della Storia. Così, per esempio, nel capitolo sulla riforma agraria il primo piano non spetta solo a Stolypin, alle prese coi rimpasti o nel braccio di ferro con lo zar per far passare la propria proposta di legge che avrebbe creato una classe di piccoli proprietari terrieri. In controcampo l’autore segue le traversie del contadino Sergej Semënov, intento a mettere in pratica la riforma stolypiniana nel paesello di Andreevskoe e costretto perciò a scontrarsi coi capivillaggio che, aggrappati alla tradizione, lo ostacolano incendiandogli il fienile, uccidendone il bestiame, rubandogli gli attrezzi. Allo stesso modo eroi della rivoluzione non sono solo i Lenin e i Trockij ma anche Fëdor Linde, sergente di reggimento snobbato dai libri di storia. Il 26 febbraio 1917 è steso a leggere in caserma quando grida e rumori esterni attirano la sua attenzione. Appena scorge alla finestra i cosacchi che sparano sulla folla inerme, Linde salta sul tavolo. È così che convince migliaia di soldati ad ammutinarsi e si mette alla testa dei reggimenti Preobraženskij, Litvanskij e Finlijandskij svolgendo un ruolo decisivo nella rivoluzione.
L’impostazione di La tragedia di un popolo deve molto, insomma, al pensiero espresso da Tolstoj nella tirata finale di Guerra e pace: la storia è la storia dei popoli, non solo dei capi e degli individui d’eccezione. In quest’ottica un contadino di Andreevskoe o un ufficiale subalterno contano quanto Napoleone. Armato di quest’idea di fondo, Figes lavora per darci un quadro dell’evento a trecentosessanta gradi, integrando diversi punti di vista e convocando in prima fila tutte le classi sociali in gioco, e crea allo stesso tempo una straordinaria coralità di figure umane, una polifonia di personaggi da romanzo russo ottocentesco. Ciò non toglie che la sua scrittura non scivoli mai nel romanzesco (“Figes non è affatto uno storico che romanza: è difficile immaginare uno storico più rispettoso delle fonti e un interprete più scrupoloso”: è di nuovo Carrère che parla) né nella fredda, accademica analisi storiografica. Che “uno dei maggiori sconvolgimenti sociali della storia”, per dirla con Hobsbawm, abbia trovato in lui il proprio interprete è la fortuna di chi legge.