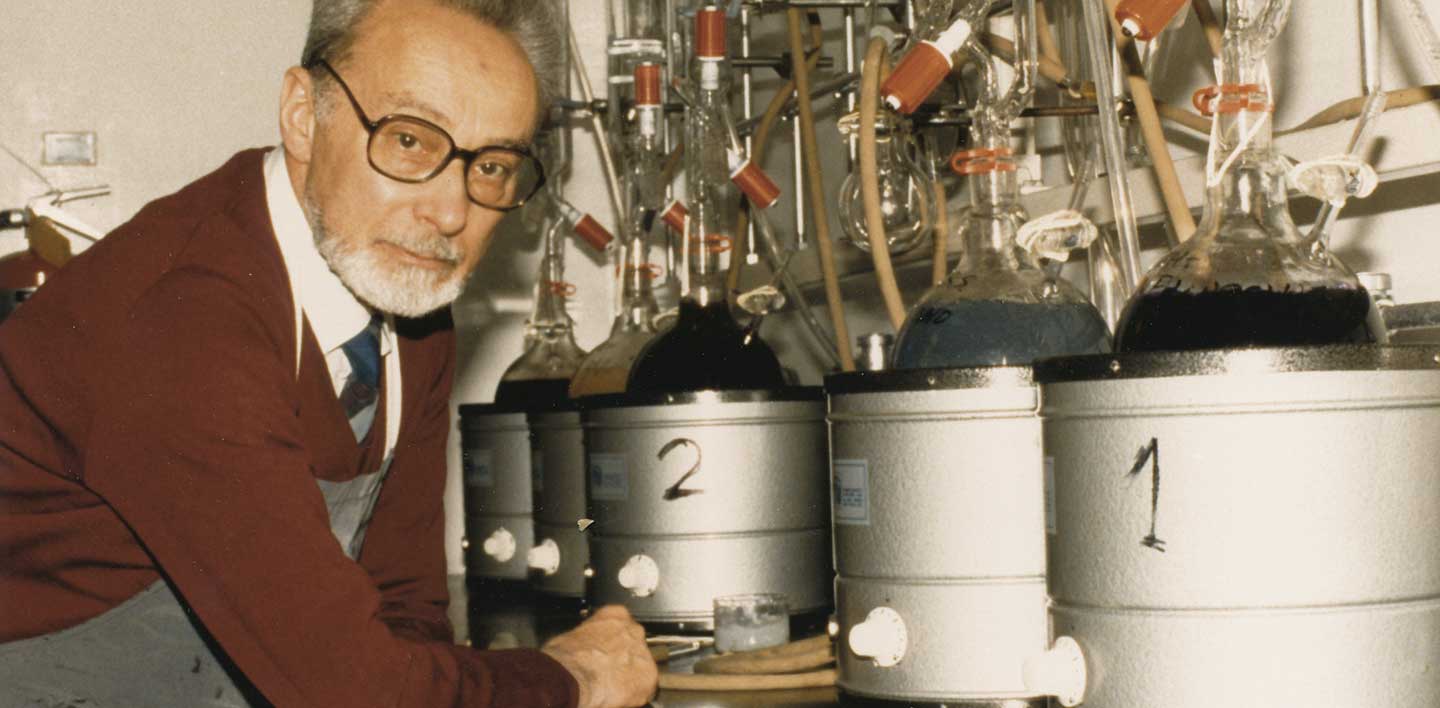
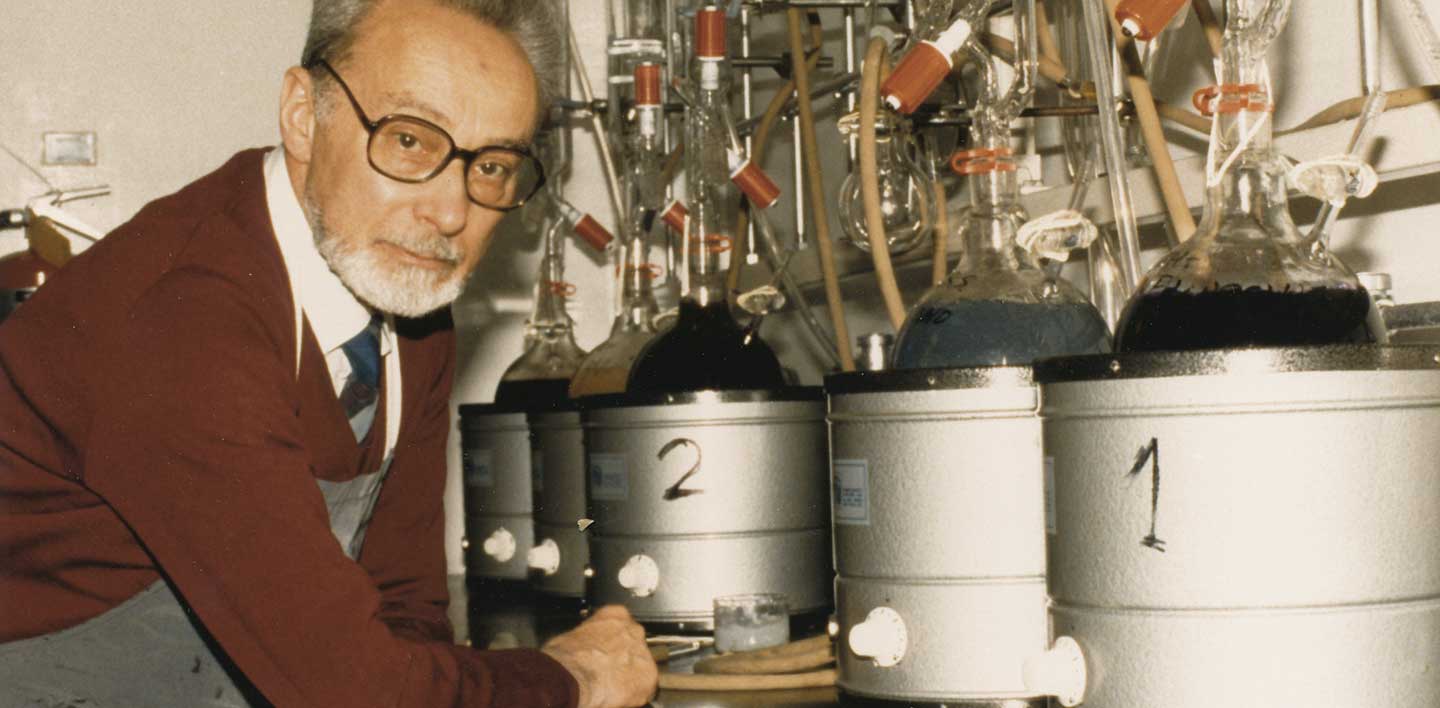
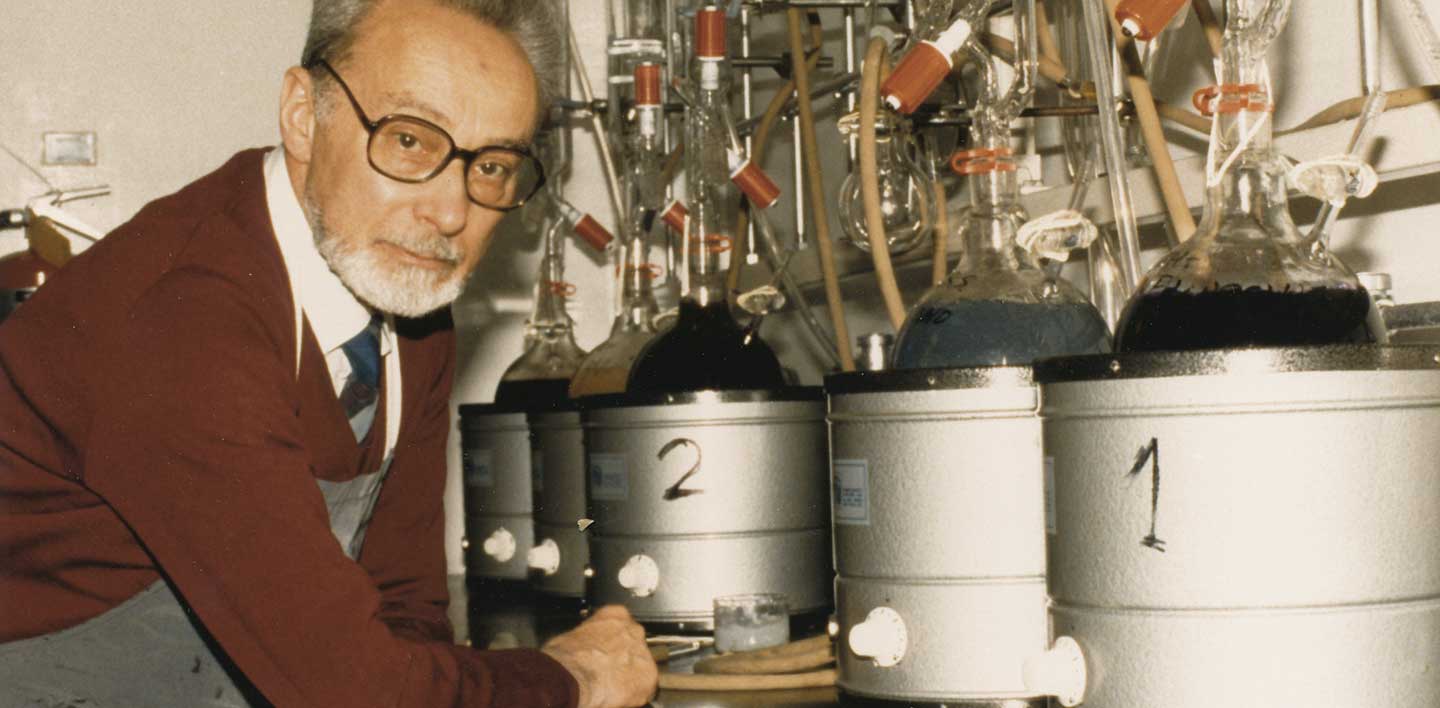
L a chiave a stella come molte delle altre opere leviane si nutre di un perpetuo dialogo con gli altri suoi testi. Quando affrontiamo uno scritto di Levi, ci viene alla mente l’immagine del formicaio (una felice definizione di Alberto Cavaglion) ovvero di una serie di testi che sono uniti gli uni agli altri e che comunicano profondamente. Non sto, in questa sede, sostenendo che Levi abbia scritto sempre lo stesso libro o un solo libro declinato in modo diverso, ma che esiste nell’autore torinese una precisa tensione interna a tenere insieme tutta la sua bibliografia.
Tornando al romanzo, in esso si raccontano alcuni episodi della vita di Libertino Faussone, montatore di gru che si trova, in una remota provincia della Unione Sovietica, a dividere le giornate libere con un chimico italiano, che non si fatica a riconoscere come Levi. Parlare di questa opera che come semplice racconto del “lavoro” non dà l’idea della complessità del testo, che nella migliore tradizione dello scrittore torinese è in primo luogo un ritratto a tutto tondo di un uomo, a partire della sua parlata.
Eh no: tutto non le posso dire. O che le dico il paese, o che le racconto il fatto: io però, fossi in lei, sceglierei il fatto, perché è un bel fatto. Lei poi, se proprio lo vuole raccontare, ci lavora sopra, lo rettifica, lo smeriglia, toglie le bavature, gli dà un po’ di bombé e tira fuori una storia.
La lingua di Faussone non è una semplice riduzione scritta del parlato piemontese (gli anacoluti, le costruzioni del parlato riportate nello scritto) ma è anche l’irruzione del linguaggio tecnico nell’ordine del discorso, come ad esempio “smerigliare”, “bavature”, “bombé” etc etc. E questo non deve stupire perché fin da Se questo è uomo Levi è stato ammaliato dalle lingue parlate e da quel senso di babelica confusione che si respirava nel lager. Un uomo si descrive in primo luogo dalla lingua che usa e dal modo in cui esso la usa e, infatti, non è un caso che il suo interlocutore, Levi stesso, dica: “Ha un vocabolario ridotto e si esprime spesso attraverso luoghi comuni, che forse gli sembrano arguti e nuovi”.
Faussone ama raccontare le storie, ma il suo modo di raccontarle non è un modo letterario o narrativo, tutt’altro. Non obbedisce alla regole della buona narrazione: “Non è un grande raccontatore: è anzi piuttosto monotono, e tende alla diminuzione e all’ellissi come se temesse di apparire esagerato, ma spesso si lasica trascinare, ed allora esagera senza rendersene conto”. Imperfezioni che generano simpatia, condivisione: Levi non lascia nulla al caso. Anche il cognome del protagonista contiene una serie di suggestioni. Alle nostre orecchie, abituate alla parlata piemontese, la parola “faussone” suona simile a “faus” ovvero un aggettivo molto usato nel dialetto per significare “falso” o “finto”. Questa spia linguistica è molto interessante perché introduce il tema dell’impostura, che è uno dei nodi nevralgici dell’opera leviana. Si pensi solo a una poesia come Cuore di Legno, in cui viene descritto un ippocastano che vive nei piccoli spazi di un corso di Torino e conduce una esistenza di impostura, fingendo di vivere come il suo fratello di montagna, ma che in realtà produce frutti non buoni da mangiare.
Il vivere in vece di tornerà fortissimo ne I sommersi e salvati (nel capitolo La vergogna), quando Levi metterà sotto la sua spietata lente d’ingrandimento quel sentimento del male di sopravvivere, ovvero di quello che vivono molto sopravvissuti che si sentono liberi ma non redenti. A questo punto anche il nome di battesimo di Faussone Libertino assume una diversa connotazione per il lettore, quasi a segnare l’idea non solo di una libertà falsa o sbagliata, ma proprio diminuita. Ci sono almeno due racconti, dei tanti dell’epopea di Faussone, che descrivono questa sorta di inquietudine, legata a quando le cose vanno male. Il primo è il capitolo introduttivo intitolato Meditato con malizia (che riprende un verso di Eliot) e un altro intitolato Il Ponte, che tra l’altro riprende il tema di una poesia coeva al libro. Ne Il Ponte come altre volte Faussone ha fatto il suo lavoro al meglio e ne è molto orgoglioso e così insieme agli altri lavoratori guarda l’opera della sua fatica.
Ero anche io sul punto, a metà della prima campata, e oltre al fresco ho sentito due altre cose che mi hanno fatto restare lì bloccato come un cane da caccia quanto punta ho sentito il ponte che mi vibrava sotto i piedi, e ho sentito come una musica […]. Mi sono sentito inquieto, […]: forse sarà anche questo un effetto del nostro mestiere, ma le cose che vibrano a noi ci piacciono poco.
C’è inquietudine in queste parole, una sorta di maleficio – il termine malizia, con cui si apre il libro, è ripetuto molte volte e indica proprio il momento in cui l’opera di ribella al montatore –, che anche Faussone non può far a meno di registrare. Noi lettori la percepiamo come un’angoscia che ogni cosa nel mondo prova su di sé e che Levi definisce come vergogna, un sentimento complesso simile all’angoscia primigenia, che pervadeva il cosmo come raccontata nei Sommersi e i salvati. Questo continuo andirivieni di temi coincidenti tra la narrazione del lager e queste storie di lavoro, ci interroga su quanto di Levi ci sia in Faussone. È chiaro che l’interlocutore che non viene mai nominato sia appunto Levi, e nel corso del libro più volte vengono chiariti alcuni aspetti della vita di questo secondo uomo, che senza alcun dubbio ce lo fanno riconoscere come l’autore.
Mi sembra però interessante questo gioco di specchi, perché è ovvio che l’autore veda in Faussone qualcosa di suo, lo senta vicino e portatore di qualcosa che lo riguarda. Levi ha sempre amato molto Conrad e nella sua auto-antologia La ricerca delle radici, a proposito di Conrad, parla dell’angoscia di dire “io” e di come da questa angoscia abbia costretto l’autore a creare Marolw che in un certo senso lo esonera da usare la prima persona. Levi è affascinato da questo sdoppiamento: e La chiave a stella è proprio il tentativo di costruire qualcosa di speculare. Non è un caso che ad un certo punto anche Levi racconti a Faussone qualcuna delle sue avventure e in una tiri in ballo Tiresia l’indovino.
Tiresia, per dirla con Levi, incappa in qualcosa di più grande di lui e la sua sapienza lo porta essere uomo e donna, a essere cieco ma profeta. È scisso come Levi stesso quando compone questo libro, indeciso se lasciare il vecchio mestiere (il chimico) per il nuovo (lo scrittore). Levi scrittore ha voluto, quindi costruirsi un alter ego, e ha giocato sul nome proprio come quando esordì nei racconti firmandoli con le pseudonimo di Malabalia. Faussone, Malabalia, la maggior parte delle scelte nominali di Levi sono all’insegna di un area semantica negativa. Se “Faussone” abbiamo detto fa pensare al falso, al finto e all’impostore, “Malabalia” significa cattiva balia, ha in sé l’idea di una madre cattiva, di latte andato a male, che ha nutrito qualcosa che è marcito (si ricordi l’accenno all’ippocastano e ai suoi frutti marci). E quale è la possibile salvezza che Levi oppone a visione di un mondo meditato con malizia? La sua visione e risposta sono molto piemontesi. A questo male lo scrittore oppone l’etica del lavoro ben fatto. Se pensiamo a quando è uscito il romanzo, comprendiamo come la tesi di Levi strida con le sirene e le riflessioni sull’operaismo che andavano di moda in quegli anni.
Se si escludono istanti prodigiosi e singoli che il destino ci può donare, l’amare il proprio lavoro costruisce la migliore approssimazione concreta alla felicità sulla terra: ma questa è una verità che non molti conoscono.
Questa idea, che comunque un lavoro se si fa lo si deve fare bene, torna anche in uno dei racconti più enigmatici di Levi dal titolo Il ritorno di Lorenzo (contenuto nella raccolta Lilit). È un racconto, ambientato nel lager (ecco ritorna quel concetto di formicaio dell’opera leviana di opere che si parlano le une con le altre e in un certo senso si completano). In questa novella il protagonista è un personaggio molto simile a Faussone, Lorenzo infatti “non era sposato, era sempre stato solo; il suo lavoro che aveva nel sangue, lo aveva invaso fino ad ostacolarlo nei rapporti umani.” Eppure questa sua qualità, questa dedizione al lavoro, lo rende umano: “Nell’ambiente violento ed abietto di Auschwitz, un uomo che aiutasse altri uomini per puro altruismo era incomprensibile, estraneo, come un salvatore venuto da cielo”.
È chiaro quindi che l’idea di lavoro esposta da Levi nei suoi racconti e ne La chiave a stella sia completamente estranea ai dibattiti del lavoro che erano presenti in quegli anni nel panorama culturale. Il lavoro non solo definisce l’uomo, ma lo salva, è un mestiere (termine molto connotato in piemontese, quasi a indicare una totale sovrapposizione tra la mansione e la persona). Non è forse un caso che Levi parli del mestiere di scrivere, mettendo in paragone le attività di Faussone e le sue attività come scrittore:
Nel mestiere di scrivere la strumentazione e i segnali di allarme sono rudimentali: non c’è neppure un equivalente affidabile della squadra e del filo a piombo. Ma se una pagina non va se ne accorge chi legge, quando ormai è troppo tardi, e allora si mette male: anche perché quella pagina è opera tua e solo tua, non hai ne scuse né pretesti, ne rispondi appieno.
In queste poche righe, che suonano come una risposta all’incipit del libro in cui Faussone parla delle storie come se fossero una gru da montare, si intravede un altro tema fondamentale del romanzo e della visione del mondo di Levi, ovvero il concetto etico della responsabilità. Concepire il proprio lavoro come un mestiere porta a sentire su di sé la responsabilità di quello che si crea. Non c’è differenza tra opera di ingegno e opera di ingegneria: per entrambe a rispondere è il singolo. In anni in cui si parlava di masse operaie, in cui si rifletteva su concetti legati alla collettività, Primo Levi consegna al lettore una diversa visione del mondo in cui conta il singolo, l’opera della sua schiena e delle sue braccia. Levi ha visto come si può ridurre un uomo in collettività, e la sua opera narrativa è il tentativo di descrivere non l’uomo, ma un uomo.
Un’ultima cosa riguarda il titolo del libro del romanzo, perché solo alla fine di questa disamina, credo che risulti più chiaro e comprensibile. Abbiamo visto che l’intero testo è dominato da una sorta di tensione tra linguaggio letterario e gergo del lavoro. Ovvio che “la chiave a stella” ci porti alla mente il cacciavite che ognuno di noi possiede per i piccoli lavoretti di casa: il titolo indica chiaramente e programmaticamente il tema del libro.