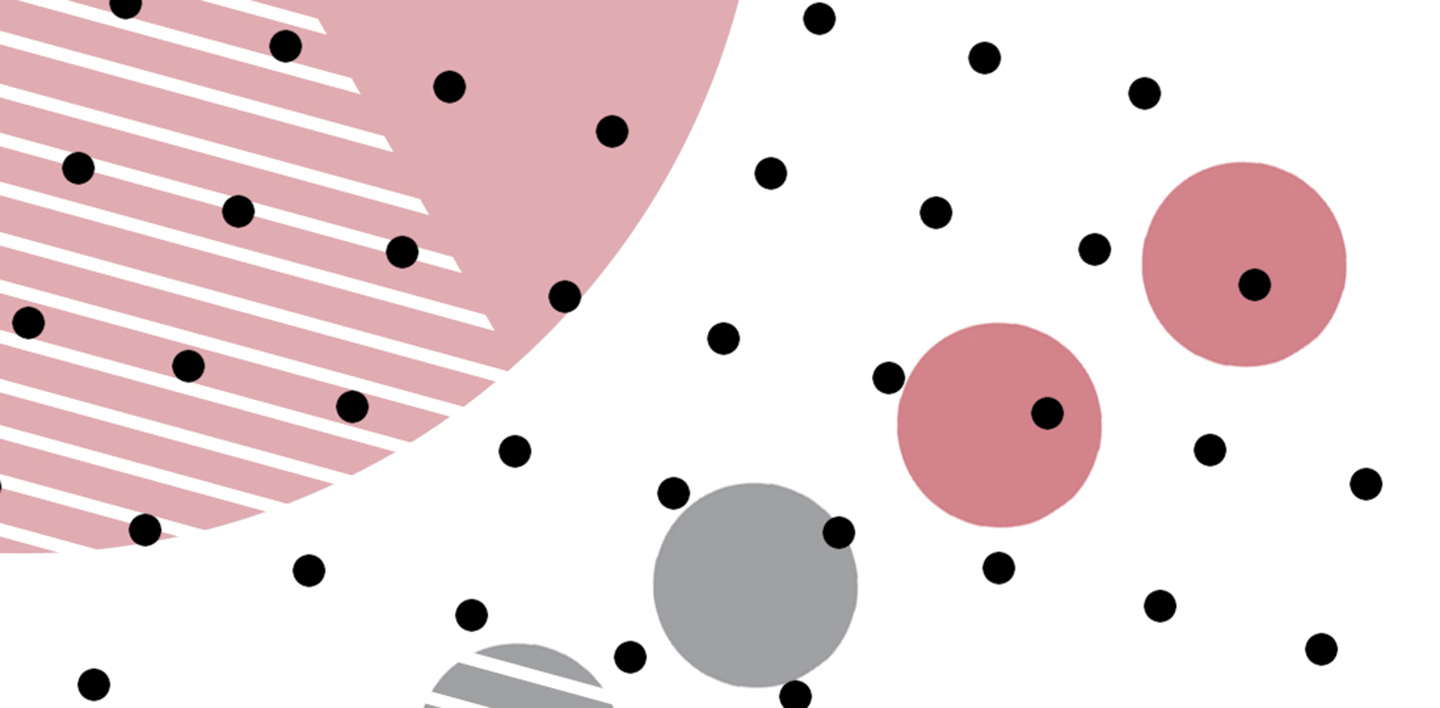
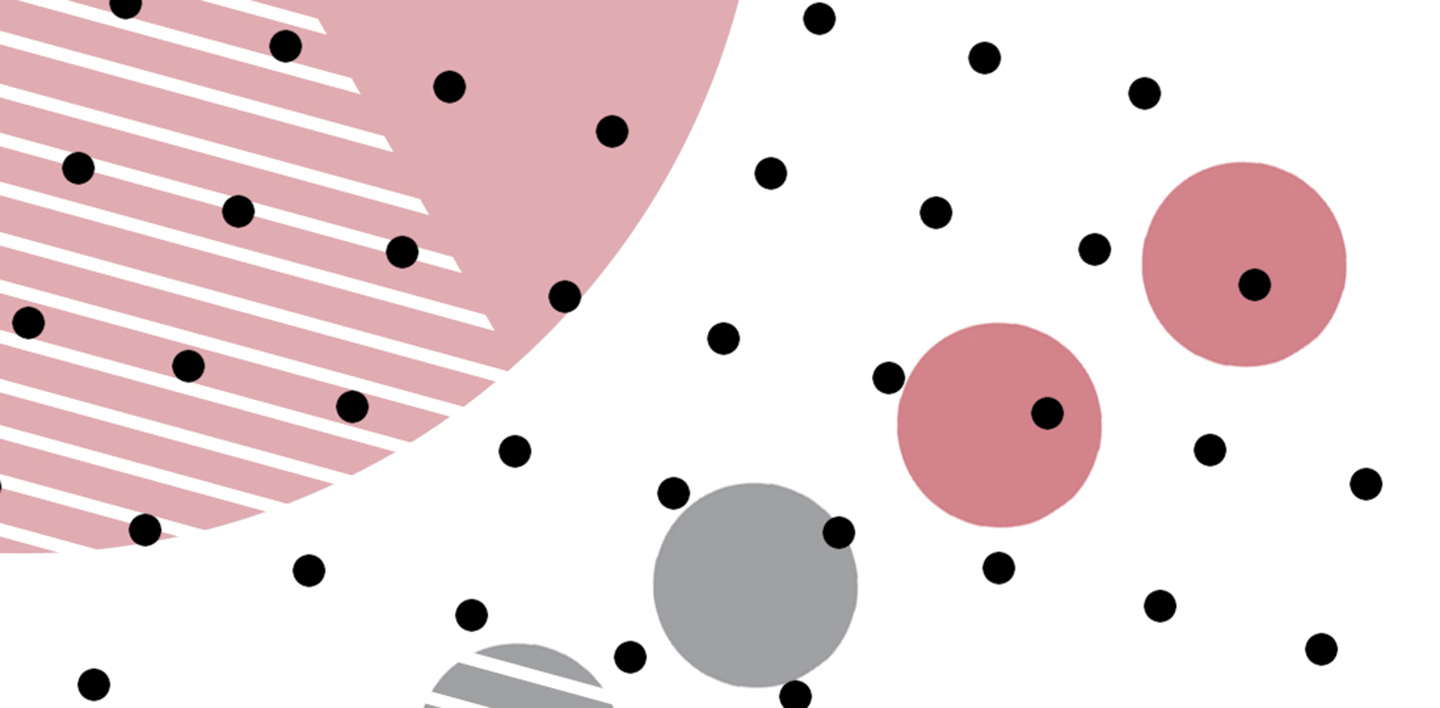
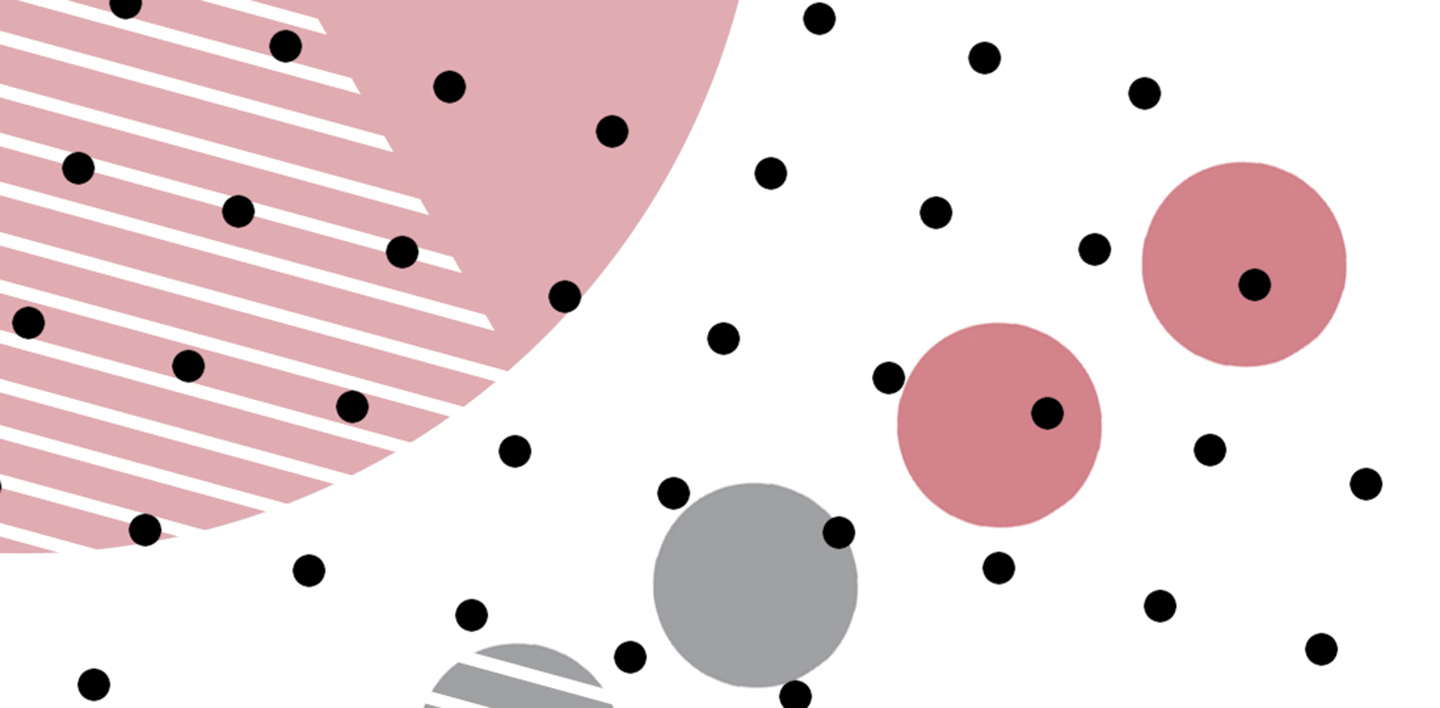
«Scrittori dal futuro» è il primo numero dell’edizione italiana della rivista letteraria Freeman’s, edito in Italia da Black Coffee. In questo numero speciale Freeman, basandosi su consigli di editor, critici, traduttori e autori internazionali, propone una lista di ventinove fra poeti, saggisti, romanzieri e scrittori di racconti che nell’attuale clima di chiusura ed esclusione sono riusciti a guardare al di là delle barriere di identità nazionale, età o genere cui la loro opera verrebbe normalmente ascritta, per rivendicare il diritto a fare della scrittura uno strumento di comunicazione globale. Quella che segue è la prefazione del primo numero.
I l primo libro che ho ricevuto in regalo è stato Il piccolo principe. In occasione del mio sesto compleanno mia nonna me ne spedì una copia per posta, l’edizione illustrata con quei meravigliosi acquerelli dipinti dall’autore in persona, Antoine de Saint-Exupéry. All’epoca non ero un gran lettore. Giravo in sella alla mia bici, fingendo che fosse una Harley. Giocavo a baseball, a calcio e non desideravo altro che diventare primo lanciatore nei Phillies. Il mondo che conoscevo iniziava e finiva a Emmaus, Pennsylvania, la città in cui abitavo con i miei. Un gigantesco albero campeggiava in giardino, dove d’inverno la neve scavava veri e propri canyon. Nei fine settimana, dopo le partite di baseball, i miei fratelli e io trangugiavamo granite alla ciliegia da Dino’s, la pizzeria accanto al WaWa, dove mio padre a volte comprava il latte a novantanove centesimi il gallone.
Poi lessi Il piccolo principe. La storia di quel pilota abbattuto che incontra un principe alieno con la sciarpa mi aprì un mondo. Non tutti gli alberi erano come quello del nostro giardino. Esistevano i baobab. I deserti. C’erano principi, aerei, asteroidi e alieni che parlavano come noi. Volpi che potevano esserti amiche o ingannarti. Ero incantato. Lessi e rilessi quel libro, sdraiato a pancia sotto sul ruvido tappeto del salotto, mentre le ore scivolavano via, invisibili. Solo ora mi rendo conto che girare quelle pagine è stato per me come decollare. Se avete mai preso un aereo, sapete come funziona: le ali deviano il flusso d’aria che le investe, creando una forza che fa sollevare l’aereo e gli permette di spiccare il volo. Eppure, ogni volta che il terreno viene a mancare sotto le ruote, lo stupore mi mozza il fiato. Che meraviglia.
All’epoca ricordo che non degnai neanche di un pensiero l’autore de Il piccolo principe. Il libro me l’aveva dato la nonna, per me poteva benissimo averlo scritto lei. Non pensai, Sto leggendo un romanzo francese, né mi congratulai con me stesso per quell’incursione nella letteratura in traduzione. Per il ragazzino che ero, in un certo senso, tutto era tradotto. Un oggetto, una persona, un’esperienza, nei libri veniva ridotto a parola. E pur restringendosi, quel mondo oltre il mio giardino, ogni giorno si espandeva. I miei mi avevano regalato un mappamondo che facevo girare sulla punta del dito come un pallone, ignaro che Saint-Exupéry avesse composto quel miracolo fatto libro dopo essersi schiantato nel Wādī al-Natrūn, in Egitto, a bordo del suo Caudron c-630 Simuon rosso e bianco, mentre tentava di stabilire un record di velocità sulla tratta Parigi-Saigon insieme all’amico André Prévot. E il tutto senza una mappa: avevano portato con sé solo un thermos di caffè e del vino (ah, i francesi!) per sopravvivere un paio di giorni. Soltanto più tardi scoprii che erano stati ingannati dai miraggi, dalle loro stesse allucinazioni, rischiando di lasciarci la pelle. A salvarli era stato un beduino di passaggio che li aveva riportati in vita attraverso metodi tradizionali di reidratazione.
Apprendendo questi dettagli dalla magnifica biografia di Saint-Exupéry curata da Stacy Schiff, qualche anno fa, il mio mondo si è spalancato per la seconda volta. Il libro di un uomo cui avevano strappato le ali, un uomo distrutto, col cuore spezzato – il nazismo l’aveva costretto a fuggire dalla Francia e suo fratello era morto – parlava alla mia vita adesso, decenni più tardi, in una zona dell’America che Saint-Exupéry non aveva mai visto, in una cittadina affollata di auto sportive, vorticanti pali di barbieri e cadenti sale per le riunioni dei veterani di guerra. Questo fatto, di per sé, mi parve magico tanto quanto l’esperienza del volo. Il mondo visto dall’alto rivela il proprio volto. Saint-Exupéry era riuscito a parlare di tirannia e perdita attraverso un libro che aveva come protagonista un alieno, e così facendo aveva permesso al me bambino di comprendere quei difficili concetti, di riconoscerne da lontano la forma. E io che pensavo di avere fra le mani una storia di amicizia e avventura.
Da adulti leggiamo in maniera diversa. Il mondo che ci circonda e le persone che ne fanno parte hanno da tempo ricevuto un nome, un’etichetta. Col passare degli anni la nostra vita acquisisce peso, parte del quale, stranamente, deriva dalla perdita. Così molti di noi vanno in cerca di un altro tipo di libri. Non possiamo farne a meno. Volare, ormai lo sappiamo, è molto pericoloso. La vita va vissuta con i piedi per terra. È per questo che, da adulti, i libri ci vengono presentati in modo diverso. Le copertine lasciano intuire il contenuto, impedendoci al contempo di prevedere ciò che accadrà fra le pagine. In quarta, autori che già conosciamo ci esortano alla lettura. Se vivete negli Stati Uniti, gran parte dei libri che leggete sarà scritta in inglese. In caso contrario, si tratterà di libri prontamente inseriti nella scia di altri autori noti provenienti da quella parte di mondo. In quanti hanno iniziato a leggere Gabriel García Márquez perché un altro scrittore colombiano ne aveva attestato la grandezza? Ebbene sì, è così che a noi lettori adulti viene presentata la maggior parte dei libri scritti nella maggior parte dei Paesi del mondo.
Queste sono soltanto alcune delle barriere che si parano dinanzi a un lettore onnivoro, cosmopolita, quello che sostengo sia il nostro stato originario. Non parlo del cosmopolitismo da jet-set, per dirla come il filosofo Paul Gilroy, quanto piuttosto della categoria sempre più nutrita che Gilroy stesso definisce nei suoi libri, quella di cui la scrittrice Aminatta Forna ha parlato di recente in una conferenza sull’argomento tenutasi a Georgetown. «Cosmopolita» ha detto «è chi possiede, o si è creato, più di un modo di vedere le cose, qualcuno la cui prospettiva non sia circoscritta ai confini dati dai valori di un’unica cultura nazionale. Cosmopoliti si può nascere, diventare, o essere costretti dall’esterno a essere». Pensateci: il migrante è cosmopolita, il rifugiato è cosmopolita, chiunque viva tra due o più luoghi, e quindi comprenda la complessa situazione in cui costoro si trovano, è cosmopolita. Che splendido concetto, specialmente in un’epoca in cui i governi, in particolar modo quello americano, basano la propria politica sulla crudeltà istituzionalizzata e sull’assunto diametralmente opposto per cui alcuni individui, in sostanza, valgono più di altri.
Leggere è un atto politico, una questione etica; lo è sempre stata, ma più che mai adesso che i governi sfoderano la violenza contro chi non rientra nella definizione più pura di cittadino e la democrazia liberale è minacciata proprio nel suo nucleo originario, l’Europa e gli Stati Uniti. È in atto una vera e propria guerra culturale contro le moltitudini, l’ibridazione, la globalità. Non voglio spingermi ad affermare che, in quest’epoca di conflitto, attraverso la lettura dobbiamo superare i confini della nostra cultura nazionale, tuttavia se lo facciamo raramente, che cosa dice questo di noi, dei nostri valori? Che cosa dice della nostra immaginazione? Se con la letteratura, con il modo in cui ne parliamo, non facciamo altro che rendere più invalicabili i confini nazionali, con che diritto pretendiamo di vivere in un mondo libero? Se non siamo in grado di immaginarlo, un mondo così, come possiamo sperare di renderlo reale?
È possibile combattere attraverso le nostre scelte di lettura? A mio parere sì, e possiamo farlo senza perdere il gusto di leggere. È sufficiente tornare a considerarla come un’esperienza più ampia, quella da cui in così tanti siamo partiti: la lettura come viatico per la sorpresa, la gioia, la complessità e la meraviglia, non come mappa immaginaria di ciò che sappiamo già. Questo numero di Freeman’s è proprio un tentativo di agevolare il suddetto ritorno. Quante volte gli esperti hanno indicato il futuro, fornendoci una lista di scrittori appartenenti a un’unica nazionalità? O a un unico genere? Ai miei occhi queste distinzioni diventano ogni giorno più intollerabili, in primo luogo perché gli scrittori, dal canto loro, non ragionano così. Senza Günter Grass, ad esempio, Salman Rushdie non avrebbe mai potuto farsi strada nel cuore di Saleem Sinai, il protagonista de I figli della mezzanotte, libro senza il quale Junot Díaz, dal canto suo, non avrebbe mai dato vita al personaggio di Oscar Wao, l’eroe dell’omonimo romanzo, cittadino negli anni di Trujillo, prima, e immigrato in America, poi. Gli scrittori, per natura, sono favorevoli alle ibridazioni, culturali e nazionali, perché scrivono con quella parte della mente con cui leggiamo da bambini.
In queste pagine si celebra la multiculturalità in ogni sua forma. La bellezza non ha mai avuto passaporto. Si presenta senza invito, è un’imbucata. Per questo ho selezionato gli scrittori presenti in questo numero senza stabilire limiti di età, sesso o lingua. Cercavo vite e carriere sul punto di decollare, autori che a mio parere devono ancora essere riconosciuti in tutta la loro grandezza e fra le cui pagine si scorge una possibilità come un faro nel buio. Vengono da esperienze e mondi diversissimi fra loro, ma non li ho selezionati in virtù di ciò che li distingueva: il più anziano è un saggista texano di settant’anni, il più giovane un romanziere francese di ventisei.